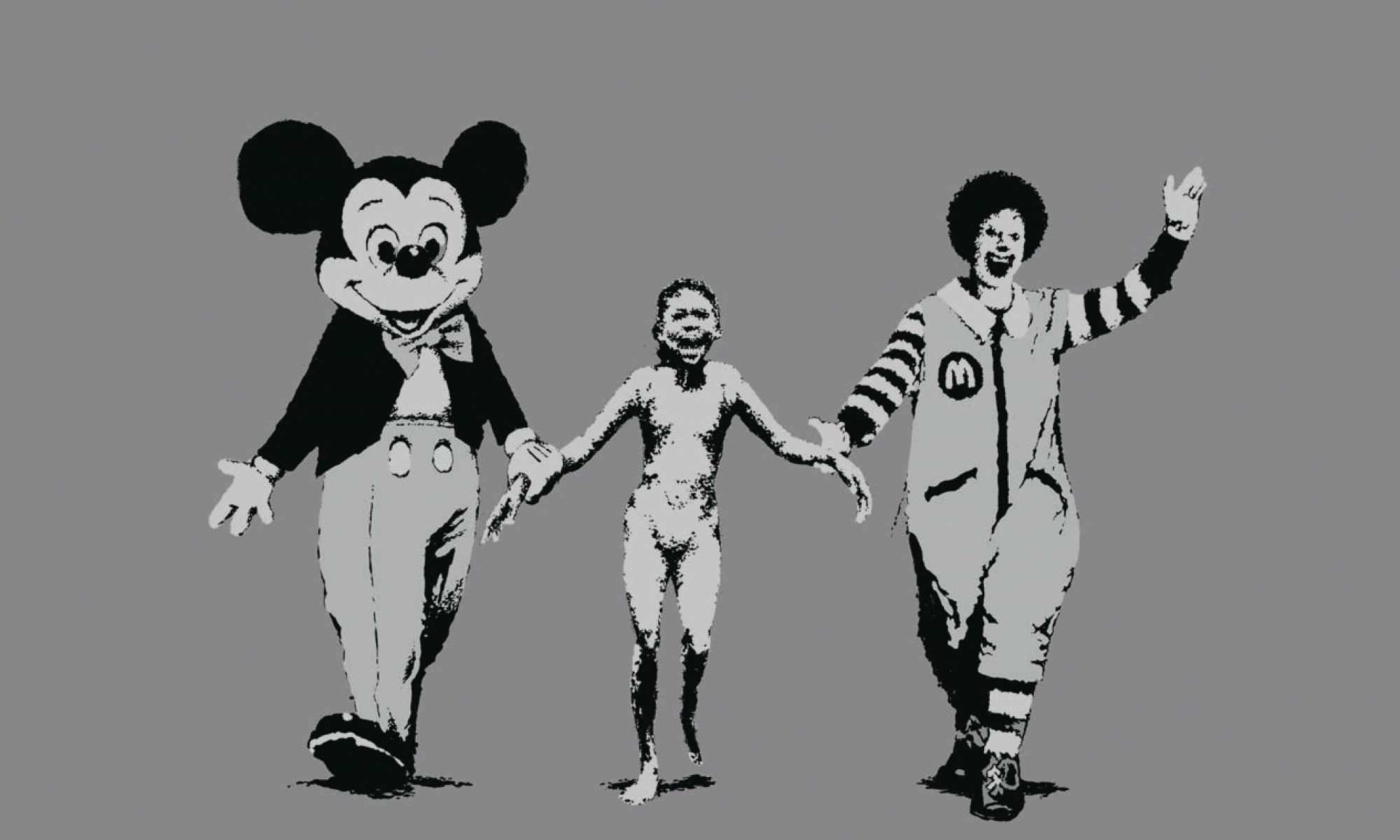Al funerale di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso a Genova, non c’erano bandiere rosse, bandiere nere, bandiere rosso-nere, niente falci, martelli e simboli dell’anarchia, ma il giallo-rosso della Roma, la squadra del suo cuore. I suoi amici hanno voluto così, forse lui stesso avrebbe voluto così se mai avesse pensato alla morte. E’ la prima volta che a coprire la bara di un giovane morto durante degli scontri con la polizia in una manifestazione politica viene usato il drappo di una squadra di calcio. E’ accaduto altre volte, semmai, che per un giovane ultrà morto in qualche scontro con ultrà rivali, una bandiera politica sia apparsa ai suoi funerali, a ricordare il suo impegno sociale. Chissà, se la linea della vita di Carlo fosse stata più lunga, e se avesse raggranellato i soldi necessari, forse, oltre lo pterodattilo, sul suo corpo ci avrebbe tatuato un gladiatore, come quello di Totti.
Forse sta tutta qui, in quel drappo giallo-rosso, la distanza, acclarata d’altronde, ma più volte conclamata, richiesta, troppo esagerata, tra il Genoa social forum, le Tute bianche, i Lilliput, quant’altro e la furia della piazza, Carlo Giuliani vivo. La distanza anche con il Black Bloc, gli scontri pensati a tavolino, le incursioni: la distanza tra la “politica”, la “militanza”, la “rappresentazione”, il “simbolico”, la “mediazione”, la “guerriglia” persino, e l’immediatezza di un corpo gettato nella mischia. Un corpo qualunque, un corpo della moltitudine.
Si è fatto un gran dire della moltitudine nei giorni di Genova, evocata prima, materializzatasi poi nell’enorme corteo di sabato 21. Ma essere moltitudine non è un corteo, una manifestazione, una rappresentazione forte di un disagio, di una protesta, di una proposta: essere moltitudine è una condizione della vita, prima di tutto, della vita di ogni giorno, della propria impotenza, disperazione, solitudine, assenza di voce, impazienza, rabbia, dolore. Della percezione di una vita di merda e di un’altra vita possibile. Dell’incapacità di trovare la mediazione necessaria, il linguaggio che permetta a questa condizione di ritrovarsi, di diventare fare sociale. La moltitudine è immediatezza. Si può partecipare in tanti a un enorme corteo ma questo non lo trasforma in una moltitudine; e non trasforma se stessi nell’appartenenza a quella moltitudine. Per alcuni, per molti, l’appartenere a un progetto, a una struttura, a un fare, rallenta la propria ansia, la incanala nella cooperazione, la modella. Per altri, altrettanto molti, non rimane nulla oltre l’occasionalità del ritrovarsi: resta un percorrere la vita a tentoni, un perdersi e disperdersi.
Carlo era stato a Roma al grande raduno romanista per la festa dello scudetto con la Ferilli e Venditti. Un milione di persone, di bandiere, sciarpe, gagliardetti, distintivi, magliette, cappellini giallo-rossi. Bambini coi padri sudati da fare schifo, ragazzine cresciute a troppi maritozzi con la panna a esibire ombelichi ingrassati, shampiste ossigenate, cocomerari coi semini ancora tra i denti, ragazzi coi capelli a nidi d’uccello sulla testa, nanetti con le scarpe con la zeppa per sembrare più alti, quelli delle lampade con il petto inanellato da tre, quattro, cinque giri di collane d’oro, tatuati dei carceri minorili, madri dalle diecimila amatriciane in una vita, quelli che passano le giornate con il culo su tutti i muretti, gente qualunque, Carlo Giuliani. Ne aveva portato indietro una bandiera donata poi a un suo amico. Quella festa, spettacolare per molti versi, è stata citata in questi giorni, per dire quanto poco oggi la politica riesca comunque a mobilitare, nonostante enormi manifestazioni, rispetto agli oppi dei popoli, il calcio di sicuro, ma perché no?, anche le giornate dei papa-boys. E quanto incolmabile sia la distanza fra chi ha “coscienza” e le “masse” instupidite. Eppure un filo sottile sottile quanto la vita di Carlo ci dice che le cose non stanno proprio così. Qualcuno, almeno uno deve averlo pensato, deve saperlo di suo, se alla manifestazione nella capitale tenutasi il 24 come in altre piazze d’Italia, accanto striscioni e bandiere di gruppo e partito ha portato una bandiera giallo-rossa. Anche questo si vede per la prima volta.
Il gruppo di giovani, tra cui Carlo Giuliani, che aveva accerchiato la camionetta dei carabinieri stava scatenando la propria furia: travi, bastoni, estintori, mani, piedi, ogni cosa veniva usata contro quella camionetta che, per il panico, per errore o che, era rimasta nella trappola. Le immagini lo dicono con evidenza. Una violenza impressionante. Un gruppo, un bloc di giovani scaricava la rabbia accumulata per altri pestaggi, per vigliacche aggressioni, per una violenza cieca che loro stessi o loro amici avevano poco prima o poco più in là subìto da una qualche carica della polizia o dei carabinieri: anche questo è rimasto evidente nelle immagini. E quanto accaduto la notte di sabato alla sede del Centro media è solo l’espressione concentrata nel tempo e nello spazio di un comportamento tenuto dalla polizia in tutti i luoghi e le occasioni a Genova: giovani donne, persone inermi che scappavano o cercavano rifugio venivano massacrate a calci, con i manganelli, con gli scudi, in cinque, in dieci, a cerchio, non appena restavano soli, non appena incappavano in un nugolo di poliziotti: anche questo è rimasto evidente nelle immagini. Il bloc è l’unica salvezza che hai nella guerra di strada, come allo stadio: se sei isolato sei perduto, se rimani vicino ai tuoi amici non sarai preda dei tuoi nemici, della polizia, delle “guardie”. E’ una legge della natura, non della politica. La camionetta era rimasta isolata: dovevano pagare. E’ una legge della natura, non della politica. Ma il livello di quella violenza non può spiegarsi nella natura di Carlo, nella natura dei suoi compagni del bloc, nella natura del comportamento del branco, nella natura della guerra di strada: il livello di quella violenza può spiegarsi solo con l’efferata ferocia dimostrata dalle forze dell’ordine, con la gratuita disponibilità al massacro, con la predeterminata volontà a intimidire, a spaventare, a impaurire, con la sensazione di impunità che da troppo tempo caratterizza le forze di polizia. Che siano state le bestie della polizia penitenziaria a fare il lavoro sporco “a freddo” ci fa solo ricordare le botte che giorno dopo giorno le squadrette somministrano ai detenuti qualunque. Usare la pistola per uccidere è stato, in questo senso, solo un gradino della scala dell’imposizione della forza comunque.
Non c’è nulla da questo punto di vista che possa avvicinare i due giovani, e che ci ricordino la loro stessa età è solo maldestra retorica: l’uno, il carabiniere è l’arroganza del potere: persino nel panico può ricorrere ad essa e in maniera micidiale; l’altro è solo la furia di chi non ha mai alcun potere, di chi per una volta vorrebbe fargliela pagare, vorrebbe vederli scappare.
Non c’è nulla da compiacere in questo, in quello scontro così ravvicinato, così crudo, così essenziale, così esemplare, anzi: c’è da averne paura, orrore. Chi in questi giorni ha gridato, ha allarmato contro una situazione da Stato sudamericano, da polizia di un golpe, ha diecimila volte ragione. Chi chiama alla mobilitazione democratica magistrati, amministratori, giornalisti, legislatori, persino poliziotti, ha diecimila volte ragione. La strada è questa, quella della mobilitazione democratica, dell’opposizione puntuale, precisa, aperta, pacifica. Abbandonati a noi stessi, alla guerra di strada, siamo preda della loro violenza cieca e della nostra stessa furia. Preda della logica del bloc, della natura.
Ma in quella vita gettata contro l’arroganza del potere e della forza, in quel corpo martoriato per terra, devono essersi riconosciuti in tanti se così forte è stato il sostegno alle mobilitazioni di questi giorni, quei tanti, questa sì una moltitudine, che giorno dopo giorno, privi dei movimenti, privi delle mediazioni, sperimentano sulla propria pelle l’arroganza delle “guardie”, i soldati del Male.
Il luglio del ’60 di Genova fu la rivolta delle magliette a strisce – la divisa della gente qualunque di quegli anni – contro i caroselli assassini delle camionette di Tambroni, il ministro degli Interni che a tutti i costi voleva far tenere il raduno fascista; mi piacerebbe che tra i colori dei popoli di Seattle e di Porto Alegre, le mani bianche, le bandiere arcobaleno, il verde ecologista, le tute bianche, le facce variopinte di indigeni del Sud America o dell’Africa, le bandiere rosse, le tute nere, si ricordasse anche il colore di Carlo: quel drappo giallo-rosso.
Lanfranco Caminiti, Roma, 27 luglio 2001