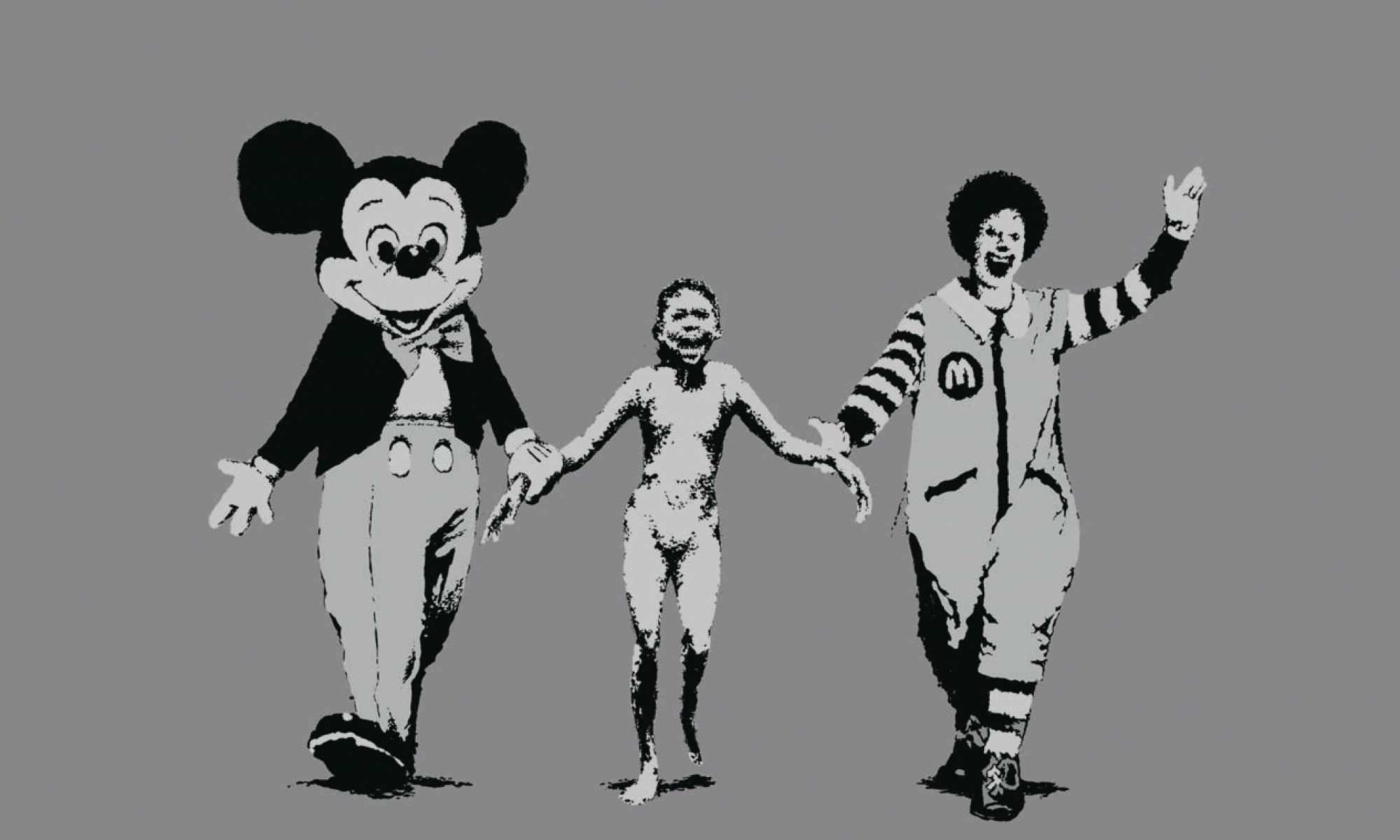Uomini neri. Ragazzi. Con i volti coperti, le felpe con il cappuccio, le bandane, i passamontagna, i berrettini, le scarpe da ginnastica, i jeans, le magliette, le canotte. Vestiti per caso. Uomini neri. Ragazzi qualunque. Come il volto che si affaccia dalla foto-tessera di Carlo Giuliani, due occhi azzurri tranquilli, un taglio di capelli ordinato, un’immobilità catturata dal flash. Solo istantanea. Capace all’improvviso di una violenza estrema. Di giocarsi in un attimo la propria vita.
Feroce. Gratuita. Demente. Assurda. Provocatoria. La violenza degli uomini neri, dei ragazzi qualunque, esplosa nelle strade e nelle piazze di Genova è stata etichettata in mille modi. Tutti giusti, tutti veri, tutti reali. Non è questo il punto. La descrizione dei comportamenti visti e accaduti a Genova, delle vetrine spaccate, dei cassonetti incendiati, delle barricate erette, degli assalti a qualunque cosa, quella di piazza, era fedele e non poteva essere altrimenti. Quando mai la violenza è fine, razionale, ragionata, consapevole, libera, spontanea?
Prezzolati, infiltrati, collusi, sospetti, strani: ciascuno ha un episodio che ha visto, fotografato, filmato o che gli è stato raccontato da persona credibile e che attesta la bontà di quella definizione. Ma ciascuno di questi dettagli – veri o verosimili – non può spiegare la complessità di quello che è accaduto: un manipolo di incursori non può mettere a ferro e fuoco una città se non facendo leva su un sentimento di devastazione già vivo e impellente e pronto a esplodere. E questo è il punto.
Non molto tempo fa, un uomo assaltò da solo con una bottiglia molotov un treno, mettendo a repentaglio la vita di innocenti passeggeri. Fu ritrovato lungo i binari, morto, forse suicida. Con difficoltà gli fu data un’identità (a Carlo Giuliani è andata meglio, i suoi amici si sono battuti per lui): nessuno sembrava conoscerlo, le persone che aveva occasionalmente frequentato erano più che altro preoccupati di prendere le distanze, era un solitario, un emarginato – dissero tutti per rassicurarsi -, viveva di elemosine, di randagismo, di sue voci nella testa. Sarebbe andato a Genova quell’uomo? Avrebbe dato fuoco alla città?
Da dove viene questa violenza, da quali viscere insondabili e non sondate, quali urla grida che non trovano orecchie per ascoltarle, quali parole non trovano lingua per parlare, modi per organizzarsi, “coscienza” per diventare politica, fare sociale, comportamenti collettivi? Dove sono i sociologi che capiscono, gli intellettuali che ragionano e discettano, i politici che rappresentano, i giornalisti che scrivono, i preti che ascoltano gli ultimi, gli infimi?
Gli uomini neri, i ragazzi qualunque colpiscono tutto, negozi, banche, insegne, merci, case, cose, poliziotti, compagni. “Il n’y a pas des innocents” – non ci sono innocenti. Nostri talebani che minano i nostri Buddha. Danno fuoco alle nostre certezze, alle nostre coordinate. Non c’è potenza nei loro gesti, non c’è potere, solo furia devastatrice. Assassina e suicida, martire e colpevole, nuda. Violenza nuda, corpi nudi. Corpi come niente, su cui una jeep può passare e ripassare, quasi fosse un sasso, una scarpa, una busta, niente. Corpi non ricoperti dall’intelligenza dei movimenti, dalla capacità di inventare rappresentazione, di trattare i media, dalle tattiche, dall’uso del tempo, dalla pazienza di saper vincere e perdere in un lungo percorso, dalla storia. Si coprono solo con i cappucci o quel che capita, sono coperti solo da un lenzuolo quando cadono e l’umana pietà li avvolge.
Figli di questo tempo, incapaci di sopportare il dolore di questo tempo, forse più degli altri raccontano di questo tempo e della sua assurdità: in fuga, dalla famiglia, dal lavoro, dalla società, persino dai centri sociali. Ai margini. A Göteborg come a Genova. Figli di questo tempo, forse più d’altro ci mostrano cosa davvero accadrebbe se i poveri del mondo, gli esclusi, gli emarginati, i reietti, gli affamati, i condannati al “braccio della morte” di una vita quotidiana miserabile, improvvisamente arrivassero come cavallette, come una delle sette piaghe, nelle nostre ricche città. Carichi d’odio cieco. Spettri essi stessi, uomini neri, evocano uno spettro, un’apocalisse.
Eppure, che movimento sarebbe mai questo nuovo, enorme, forte, che nasce da Seattle e da Porto Alegre, che raccoglie gli operai americani e i contadini brasiliani, Internet e gli aiuti in medicine per un villaggio dell’Africa, che si preoccupa dei prezzi del caffè e degli OGM, del Chiapas e del copyright, se non ascoltasse anche loro, le loro ragioni, il loro dolore, la loro furia? Che movimento sarebbe mai questo se non fosse in grado di affrontare la paura che incutono, la loro stessa paura? La nostra stessa paura. La nostra stessa impazienza. Che movimento sarebbe mai questo se sembrasse solo in grado di “preparare le barricate e chiamare la polizia per rimuoverle”?
In un luglio di quaranta anni fa, a Torino, in piazza Statuto, durante lo sciopero degli operai Fiat, disoccupati, meridionali, operai, nullafacenti, curiosi assaltarono una sede sindacale della Uil al culmine di una esasperazione, per il lavoro, per la servitù quotidiana, per l’emarginazione cui erano oggetto in una città “perbene”. L’Unità del 9 luglio definirà la rivolta “tentativi teppistici e provocatori”, ed i manifestanti “elementi incontrollati ed esasperati”, “piccoli gruppi di irresponsabili”, “giovani scalmanati”, “anarchici, internazionalisti”. Anche allora si parlò di infiltrati, di provocatori, di fascisti, di aderenti ai sindacati gialli: ci furono foto e testimonianze. E molti di questi dettagli erano proprio veri. C’erano provocatori e fascisti, anche. Ma questo non poteva dar ragione di una “frattura” così evidente, lampante, significativa. Persino Panzieri, dei “Quaderni rossi”, aveva sospetti e perplessità, lui che più d’altri aveva lavorato e scritto e pensato alla comprensione dei nuovi fenomeni legati al lavoro operaio. Nacque in quella piazza, in quelle giornate un movimento operaio nuovo, che attraversò tutti gli anni sessanta e settanta e ha segnato significativamente non solo il pensiero “operaista” ma il nostro paese. Qui, però, non si vuol dire che nelle devastazioni di Genova si deve leggere un nuovo movimento sociale, ma che gli attrezzi della comprensione devono andare più in profondo di quelli che banalmente si usano quando appare qualcosa di inaspettato e che intimidisce forse anche per questo, una coazione a ripetere quel “infiltrati, provocatori, fascisti”.
I G8 finiscono o saranno diversi. E’ una grande vittoria dei movimenti. Come d’altronde Genova è stata una grande manifestazione di forza dei movimenti. Ma se i G8 finiscono è anche per loro. Per gli uomini neri. Per i ragazzi qualunque e la loro furia.
Lanfranco Camminiti, Roma, 22 luglio 2001