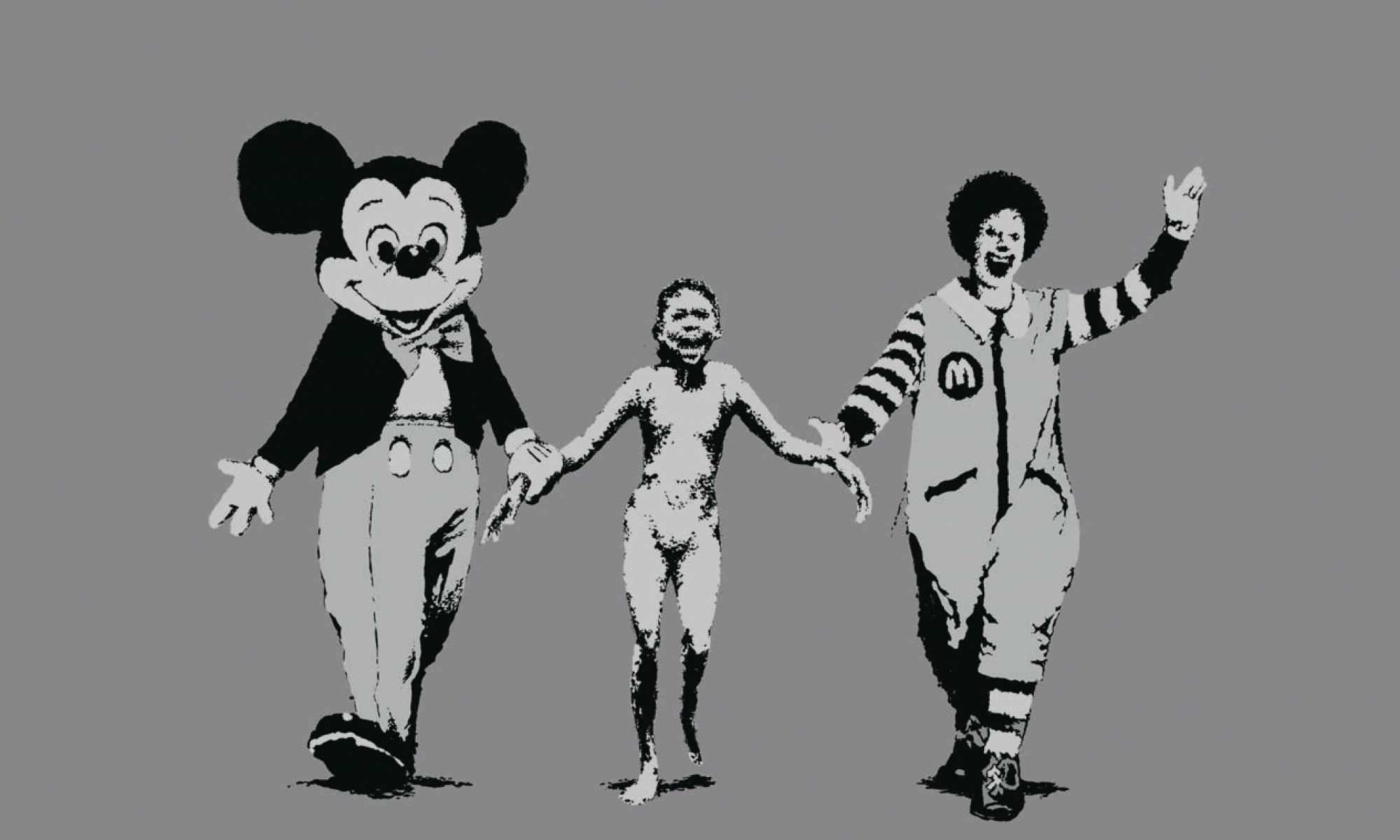di Marco Philopat su Carmilla on line
 Sono
Sono
passati esattamente cinquant’anni dalla rivolta dei ragazzi in
maglietta a strisce scesi piazza a Genova per impedire un congresso di
neofascisti. Un convegno voluto anche dall’allora governo del
democristiano Tambroni, che da pochi mesi era diventato presidente del
Consiglio grazie ai 14 voti dei parlamentari dell’Msi. La determinazione
dei manifestanti fecero fallire quel tentativo di sdoganare, per la
prima volta dal dopoguerra, gli eredi del tragico ventennio. Quel
convegno fu infatti annullato. Nell’estate del 1960 ci fu un terremoto,
di quelli imprevisti, violento e allo stesso tempo liberatorio. In prima
fila negli scontri di piazza, da Genova a Catania, da Reggio Emilia a
Palermo, da Roma a Bologna, c’erano giovani sui vent’anni, operai figli
di operai che pagarono cara la loro voglia di farsi sentire. La pagarono
con il sangue. In undici rimasero sull’asfalto, crivellati dalle
sventagliate dei mitra e dai colpi di pistola. Altre centinaia finirono
in ospedale o sul banco degli imputati come pericolosi sovversivi e
condannati a scontare anni di carcere. Sapevano di rischiare grosso
eppure scesero in piazza convinti che andasse fatto, che quello era il
loro dovere, l’unico modo per dire no al ripetersi della storia. Per
questo motivo i ragazzi con le magliette a strisce rimasero impresse nel
mio cervello appena ne venni a conoscenza.
Sentii parlare di loro, per la prima volta in vita mia, quando
indossavo con orgoglio la mia nera corazza punk. Fu il libraio Primo
Moroni che mi spiegò bene cosa accadde il 30 giugno 1960 a Genova.
“Andammo sulle barricate a fare a cazzotti con i celerini e carabinieri
che difendevano i fascisti. Eravamo tutti giovani, generosi e
intransigenti, portavamo i jeans, avevamo il mito dell’America e siccome
i soldi in tasca erano pochi ci vestimmo con delle magliette comprate
per trecento lire nei grandi magazzini. Non ci interessava una vita
passata solo lavorando, preferivano guadagnare meno ma avere più tempo
libero, però quando ci fu da protestare non ci tirammo certo indietro.”
Era uno dei suoi strepitosi racconti orali che per noi ventenni di
allora rappresentava una specie di rappresentazione cinematografica a
dir poco epica, con i moti dei movimenti operai come protagonisti. C’era
stato anche lui a Genova quando aveva 24 anni e partecipò agli scontri
in prima fila dopo aver mal interpretato una telefonata del
responsabile del servizio d’ordine di una sezione della Fgci milanese
alla quale era iscritto. Inutile dire che per noi punk, che
consideravamo i nostri vestiti come uno dei pochi strumenti per
esprimere rabbia e ribellione, quelle magliette a strisce furono una
precisa indicazione sui nostri futuri doveri. D’altronde, come tentò
sempre di sottolinearci Primo, non avevamo inventato proprio niente. Già
il grande poster incorniciato che il libraio teneva alla sue spalle ci
consigliava di guardare un po’ oltre la nostra divisa. Era infatti una
foto d’epoca che ritraeva la Banda Bonnot, anarchici francesi nonché
rapinatori di banca che vestivano in nero come noi, che vivevano in una
comune ed erano vegetariani come noi. (Ai quei tempi noi punk stavamo
tutti al Virus di via Correggio). A Milano poi c’erano stati i giubbotti
di pelle della Volante Rossa, i capelloni beat che inneggiavano al
libero amore, gli studenti con l’eskimo e infine i trench bianchi della
famosa banda Bellini…
Le magliette a strisce orizzontali bianche e blu o bianche e rosse
furono un segno distintivo che riunì i giovani contro il ritorno del
fascismo, in una lotta fino all’ultimo sangue come quello dei Morti
di Reggio Emilia, (7 luglio 1960), immortalati nella celebre
canzone di Fausto Amodei.
Cosa portò alcuni ragazzi a scegliere un indumento come simbolo di una
rivolta contro l’autorità costituita? Cosa li mosse? Non erano bandiere
rosse quelle che sventolavano, erano semplici magliette comprate al
discount. Ma soprattutto perché dopo il 1960 non ci fu più niente di
così dirompente nel rapporto tra i simboli della rivolta e l’impegno
politico?
Dopo tanti anni si potrebbe anche affermare che noi non siamo stati
capaci di tramandare l’importanza dell’adottare nuovi simboli in grado
di rappresentare un’opposizione intransigente alle attuali derive
totalitarie. Resta il fatto che i ragazzi con le magliette a strisce non
furono mai così irrimediabilmente ostacolati dai loro rappresentanti
istituzionali come invece capitò alla mia generazione. Per farvi un
esempio vi vorrei riportare le parole che l’allora deputato del Psi
Sandro Pertini, pronunciò a Genova il 28 giugno 1960. Sarà ricordato
come “u brighettu”, il fiammifero, a significare che accese la fiamma
della sollevazione popolare. Sandro Pertini arrivò attraversò Piazza
della Vittoria a Genova strinse la mano ai vecchi compagni partigiani e
salì sul palco accolto dall’ovazione di trentamila antifascisti. “Le
autorità romane sono impegnate a trovare quelli che ritengono i
sobillatori, gli iniziatori, i capi di queste manifestazione di
antifascismo” gridò con tutto il fiato che aveva in gola. “Non c’è
bisogno che s’affannino. Lo dirò io chi sono i nostri sobillatori.
Eccoli qui: sono i fucilati del Turchino, della Benedicta, dell’Olivetta
e di Cravasco, sono i torturati della Casa dello studente, che risuona
ancora delle urla strazianti delle vittime e delle risate sadiche dei
torturatori.” Gli applausi lo interruppero per diversi minuti. Poi
Pertinì continuò. “Io nego che i missini abbiano il diritto di tenere a
Genova il loro congresso. Ogni iniziativa. ogni atto, ogni
manifestazione di quel movimento è una chiara esaltazione del fascismo.
Si tratta, del resto, di un congresso qui convocato, non per discutere
ma per provocare e contrapporre un passato vergognoso ai valori politici
e morali della Resistenza” Pertini chiese a tutti di scendere in piazza
per tutelare la libertà conquistata con il sacrificio di migliaia di
innocenti. “Oggi i fascisti la fanno da padroni, sono di nuovo al
governo, giungono addirittura a qualificare come un delitto l’esecuzione
di Mussolini. Ebbene, io mi vanto di aver ordinato la fucilazione di
Mussolini, perché io e gli altri membri del CLN non abbiamo fatto altro
che firmare una condanna a morte, pronunciata dal popolo italiano
vent’anni prima.” Pertini comunque non fu il solo a stare a fianco dei
ragazzi in rivolta, lo dimostra il fatto che al processo sui fatti di
Genova e quelli siciliani o di Reggio Emilia, gli imputati per gli
scontri furono difesi dai migliori avvocati dell’apparato del Pci, tra
cui Umberto Terracini che aveva redatto la Costituzione e il capo
partigiano Giovanbattista Lazagna. Inoltre i vertici del partito
togliattiano cominciarono una seria autocritica interna per capire lo
scollamento tra il movimento spontaneo e la strategia del Pci. “Non
bisogna perdere il contatto con le masse entrate in lotta” dicevano. Le
testimonianze che dimostrano tutta la lacerazione di quel dibattito sono
riportate da molti libri. Il primo è uscito da qualche settimana e
s’intitola Al tempo di Tambroni di Annibale Paloscia per
Mursia, poi c’è lo stupendo romanzo del 2008, L’estate delle
magliette a strisce di Diego Colombo per Sedizioni e infine un
capitolo del breviario di racconti orali di Cesare Bermani, Il
nemico interno per Odradek, dove potete trovare le ragioni della
telefonata mal interpretata da Primo Moroni. Vedere i dirigenti del Pci
barcamenarsi tra i Teddy boy e le magliette a strisce presumibilmente
usate da personaggi trasgressivi come Picasso e Brigitte Bardot, fa
oggi morire dal ridere. Emilio Sereni s’interrogava sulla “gioventù
sotto una direzione che non è la nostra.” E in effetti le iscrizioni
alla Fgci erano in calo mostruoso (365 mila nel ’56, 229 mila nel
1960). C’era chi accusava i giovani di aver subito una “deteriore
influenza dal clericalismo e dall’americanismo” e chi invece sosteneva
il dialogo, certamente non fu facile per tutti loro controbattere alle
tesi dello scrittore Carlo Levi apparse sul settimanale “ABC”.
“Spingere con la forza e non tacere. Dovete usare la vostra forza per
sovvertire, protestare. Fatelo voi che siete giovani.” diceva Levi e
quindi, rivolto ai dirigenti del Pci notava. “Questi fatti impongono a
tutti un esame approfondito, e l’elaborazione, o la modificazione di
programmi e di metodi: lo studio preciso di fini concreti, nati dalla
coscienza popolare. La fiducia, rinata attraverso l’azione, è un bene
prezioso che non può essere deluso e dissipato”. Su quelle magliette a
strisce, e in senso più ampio sulla passione per i modelli trasgressivi
dell’american way of life trasmessi dai film come The Wild one o
con le scosse del Rock ‘n’ Roll, nessuno dei dirigenti comunisti o
socialisti riuscì mai a capirci qualcosa. Eppure non erano in pochi
quelli che avevano compreso quanto quei modelli erano sedimentati tra i
giovani e quanti immaginari di società diverse e vissuti generazionali
affascinanti avessero sprigionato.
Negli ultimi 50 anni i partiti che avrebbe dovuto rappresentare i
diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli della società si sono
trasferiti piano piano dall’altra parte della barricata, ormai è palese.
Durante gli anni Settanta furono impegnati a spegnere ogni fuoco
possibile che nasceva spontaneo tra le masse diseredate, ripiegando
sulla criminalizzazione dei sobillatori, come a dire: “Se non ci fossero
gli estremisti di sinistra, il mondo sarebbe perfetto.” Poi, dopo
essersi battuti soprattutto per dimostrare di essere all’altezza della
modernità, di essere persone raffinate e di buone maniere e amici del
business globale, hanno raggiunto l’apice nel dopo G8 2001, (ancora una
volta a Genova), con la deleteria questione della nonviolenza. E lì è
crollata la maschera.
È vero che da parte nostra, e intendo ragionare sui quei pochi punk e
autonomi che restarono a galla durante gli anni del riflusso, non ci fu
la capacità di smontare i meccanismi di cancrena sociale che si
svilupparono attorno alle nostre roccaforti liberate. Forse non capimmo
bene ciò che si nascondeva dietro la gelateria dei gusti colorati e
degli stili di vita che stava prendendo piede nelle nuove generazioni.
Non capimmo neanche la danza degli spettri dei rave nel limbo
fluorescente di una bolla destinata prima o poi a scoppiare, senz’altro
fummo travolti dal bling bling degli anni ’00 con il luccicare delle
fibbie dolcegabbana a simboleggiare la resa definitiva del nostro
futuro. Non sta a me provare a fare analisi, sono solo un grande
appassionato delle magliette a strisce e di tutte le creature simili che
si sono susseguite nel corso del tempo. Però di una cosa ne sono
sicuro, noi fummo contrastati in primo luogo da ciò che rimaneva
dell’apparato dell’ex partito comunista italiano teso nella sempre più
spasmodica ricerca di un paese normale…
Purtroppo oggi l’orologio della storia è ritornato brutalmente indietro e
i fascisti non solo sono stati ampiamente sdoganati, ma hanno
addirittura riconquistato il potere e l’egemonia culturale. Ora che
l’insolente corruzione dei politicanti e la tracotanza padronale hanno
dilagato, sono ancora pochi coloro disposti a non naufragare di fronte
alla paura nei confronti della passione per la libertà e l’uguaglianza. E
noi continuiamo a essere orfani di quelle magliette strisce, che oltre a
difendere i diritti già acquisiti, riuscirono a rilanciare sul futuro
per conquistarne nuovi.
Per sua stessa natura la giovinezza è stata da sempre incaricata
di rappresentare il futuro: la perenne caratterizzazione mediatica
dell’adolescente come genio o mostro continua a veicolare le speranze e
le paure degli adulti su quanto accadrà in futuro. Ignorare chi spicca
come precursore a favore di chi resta fedele allo status quo significa
rifiutare l’impegno preso con il futuro, se non addirittura equivocare
la natura stessa della giovinezza. Io vado fiero del mio romanticismo in
materia, quanto meno perché spero in un mondo migliore.
Jon Savage
L’invenzione dei giovani
Intervento dedicato a Valerio Marchi, storico, skinhead, ultrà della
Roma, studioso del conflitto e fratello dei ragazzi di strada, che verrà
ricordato in questi
giorni nel suo quartiere San Lorenzo di Roma.