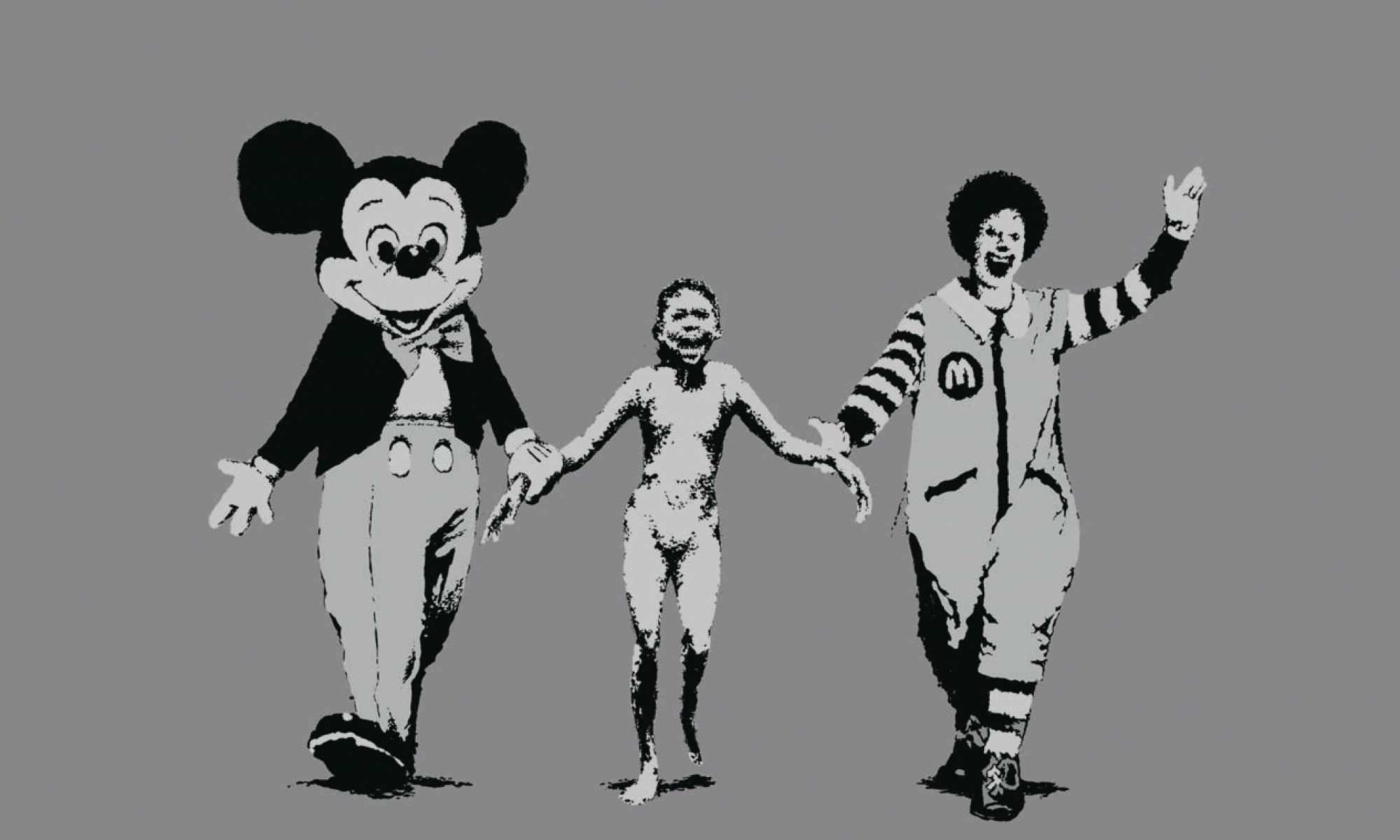E' uscito in questi giorni, come da recente post, il primo di tre libri di DeriveApprodi sull'Autonomia Operaia.
A me è arrivato ieri ed ho avuto tempo solo per una manciata di pagine, al di là dell'indice e di uno sguardo sugli autori dei saggi (tutte vecchie conoscenze :).
Ma, sempre ieri, ho scovato il sito di Lanfranco Camminiti, curatore del libro con Sergio Bianchi; sito assai interessante, e su cui si trova il suo saggio di introduzione al libro.
Eccolo qui sotto:
Il fattore A
 Negli anni Sessanta e Settanta l’Italia è stata attraversata da un conflitto sociale di durata e intensità che non hanno uguali nella storia più recente. Non v’è stato luogo di produzione che non sia stato toccato da una rivendicazione, da un picchetto, da un corteo interno, da un sabotaggio, da uno sciopero, non v’è stato città o paese o quartiere che non abbia visto una lotta, una manifestazione, un blocco stradale, non v’è stato bisogno sociale che non sia stato organizzato e imposto, non v’è stato istituto scolastico o facoltà universitaria che non abbia visto un’assemblea, un seminario autogestito di studio o un’occupazione, non v’è stata relazione sociale, economica, familiare, personale che non sia stata messa in crisi, non v’è stato luogo di cultura o di comunicazione o di informazione dove non ci si sia interrogati sul senso e il modo del proprio ruolo, non v’è stata autorità che non sia stata rivoltata come un calzino, non v’è stato albo o corporazione o mestiere o professione che non sia stato messo in mora. Non v’è stato lavoro che non sia andato a pezzi. Non v’è stata istituzione che non sia stata spernacchiata. Non v’è stato sindacato o partito che non sia stato fischiato. Non v’è stata piazza che non abbia ospitato uno scontro. Non v’è stata struttura di organizzazione politica che non sia stata sperimentata, non v’è stata forma di lotta che non sia stata agita.
Negli anni Sessanta e Settanta l’Italia è stata attraversata da un conflitto sociale di durata e intensità che non hanno uguali nella storia più recente. Non v’è stato luogo di produzione che non sia stato toccato da una rivendicazione, da un picchetto, da un corteo interno, da un sabotaggio, da uno sciopero, non v’è stato città o paese o quartiere che non abbia visto una lotta, una manifestazione, un blocco stradale, non v’è stato bisogno sociale che non sia stato organizzato e imposto, non v’è stato istituto scolastico o facoltà universitaria che non abbia visto un’assemblea, un seminario autogestito di studio o un’occupazione, non v’è stata relazione sociale, economica, familiare, personale che non sia stata messa in crisi, non v’è stato luogo di cultura o di comunicazione o di informazione dove non ci si sia interrogati sul senso e il modo del proprio ruolo, non v’è stata autorità che non sia stata rivoltata come un calzino, non v’è stato albo o corporazione o mestiere o professione che non sia stato messo in mora. Non v’è stato lavoro che non sia andato a pezzi. Non v’è stata istituzione che non sia stata spernacchiata. Non v’è stato sindacato o partito che non sia stato fischiato. Non v’è stata piazza che non abbia ospitato uno scontro. Non v’è stata struttura di organizzazione politica che non sia stata sperimentata, non v’è stata forma di lotta che non sia stata agita. Tutto l’immaginario della rivoluzione è precipitato qui: non v’è stata parola che non sia stata detta, non v’è stato gesto che non sia stato compiuto. Non v’è stata teoria che non sia stata teorizzata. Non v’è stata lotta nel mondo di cui non ci si sia fatti carico e non si sia stati fratelli almeno per un giorno. Tutti i sogni e tutti gli incubi delle rivoluzioni si sono fatti carne qui.
Perché tutto questo sia accaduto proprio in Italia e non altrove, poniamo in Inghilterra, in Francia, negli Stati uniti, in Brasile o in India, è per me decisamente un mistero. Però mi pare un quesito intrigante, questa anomalia della geografia e della storia, della politica. Più intrigante delle congiure di palazzo, delle beghe e delle camarille, della «guerra coperta» e sporca fra patto atlantico e blocco sovietico. Non che in Francia, negli Stati uniti o in India non siano accadute cose straordinarie: con tutta evidenza, quello è stato un periodo di grandi rivolgimenti in tutto il «mondo conosciuto». Ma queste cose straordinarie o sono durate poco quando hanno avuto un coinvolgimento sociale significativo o hanno interessato territori e soggetti sociali circoscritti, pur anche estesi, quando sono durate. Non c’è un «caso» di una singola nazione e per un tempo così lungo che abbia visto un livello di scontro tra classi e un coinvolgimento sociale paragonabili a quanto accaduto in Italia. Questa è l’anomalia italiana.
Che tutto questo abbia prodotto una profonda trasformazione di questo paese è davvero difficile negarlo adesso. Che tutto questo abbia davvero prodotto una profonda trasformazione di questo paese è difficile riconoscerlo adesso.
Avere avuto il privilegio di vivere quel tempo, ed esservi sopravvissuto, non è di per sé sufficiente a costituire una «fonte». Le forti emozioni – anche uno stato di grazia – travisano l’osservazione. E, nello stesso tempo, la domanda sul perché tutto questo sia accaduto proprio in Italia mi pare piena di senso e interesse e ancora aperta. Così, quando gli storici che verranno avranno l’agio di studiare quel tempo e troveranno i mille fili che legano le rivendicazioni della Fiat di Torino o le occupazioni di case a Roma o le battaglie di strada contro il colera a Napoli con le lotte della Ford di Colonia, gli studenti dell’università di Kent, l’offensiva del Viet, i Montoneros uruguagi, il Maggio francese, i cantieri di Danzica, il Cile di Allende, i contadini del Kerala o dello Hunan o chissache, probabilmente non potranno d’altra parte che constatare la specificità tutta italiana. E magari saranno in grado di trovare delle risposte più convincenti di quella che d’acchito potrebbe ascriverla al «carattere» nazionale. Forse.
1. Forse.
Forse un processo di industrializzazione e modernizzazione troppo accelerato, che ha squassato in poco tempo equilibri secolari, squinternando rapidamente tutte le reti di tenuta delle relazioni sociali fra classi e territori e provocando così una serie ininterrotta di smottamenti, di sommovimenti tellurici, che hanno interamente modificato la crosta dei comportamenti, quelli minuti, quelli quotidiani, quelli del buongiorno e buonasera, laddove invece in altre nazioni si è assistito a eruzioni tanto improvvise quanto presto sedimentate, perché più consolidata la precedente stratificazione, dato che quello stesso processo era stato lento e continuo, oppure, laddove altrettanto rapido, la tenuta sociale era più solida, per fede o per natura, e invece qui la terra ballava e ballava senza sosta, senza requie, e non c’era più l’ossequio che altro passava per la testa, pensieri mai immaginati prima perché ogni modernità porta i suoi pensieri e non facevi in tempo a pensare una cosa che già ne arrivava un’altra, così si affollavano tutti in una volta e non c’era nemmeno spazio nella testa per tutti quei pensieri e allora scappavano fuori e la prima cosa che si chiedevano, una volta fuori, in piazza per così dire, quei pensieri, era dove portava tutta quella modernità, di cui intanto si godeva, che andava consumandosi.
Forse una mobilità interna troppo spinta, un migrare dal sud verso il nord, dalla periferia verso il centro, dalle campagne alle città, dall’osso verso la polpa, dalle dorsali verso i litorali, e viceversa, per lo sviluppo ora concentrato ora diffuso della fabbrica, che chiedeva braccia qui o lì o non ne voleva più qui per averne bisogno lì, per l’urbanizzazione improvvisa e spesso improvvisata, per lo spengersi dell’attività agricola e artigiana, tutto un muoversi per andare dove si diceva ci fosse una vita migliore che migliore doveva essere per forza visto che quest’altra era così e così, per treni, per corriere, per automobili, per navi, tutto un migrare di uccelli che annunciava chissà quali stagioni e rendeva se stessi viaggiatori senza viaggio e piuttosto dei pellegrini e ogni posto finalmente vicino e anche irrimediabilmente lontano, mai visto prima quello dove si arrivava e ormai irriconoscibile dopo quello da cui si veniva, e si trapiantavano comportamenti antichi dove c’era il nuovo e ci si faceva portatori di comportamenti nuovi dove c’era l’antico, e questa circolazione di uomini era tutto un racconto di meraviglie, perché il dolore si fa fatica a spiegarlo e c’è pudore e non si crea stupore in chi ascolta ma solo compassione, e invece se ti fai portatore di ciò che è grandioso e stupefacente allora c’è ammirazione, e tutto questo circolare e pascolare di uomini e parole, tutto questo conoscere e incantarsi da qualche parte doveva pure portare, bisognava pure fermarsi un giorno e chiedersi l’un l’altro quale destinazione.
Forse l’alfabetizzazione e la scolarizzazione massicce tutto d’un botto che coinvolgevano e uno e una in ogni famiglia e ora c’era l’alletterato che era tutta una fierezza del sangue e tutto un premio alla fatica spesa per addottorarlo e tutte le salsicce e le damigiane d’olio perché fosse migliore di se stessi e uguale ai figli di, perché ci fosse insomma una salita, una ascensione, anche se poi ce lo si ritrovava strano ma proprio strano che forse era la troppa soma dello studio a stracangiarli, i figli, ché il nerbo era altro, i muscoli erano geneticamente allenati ad altro, a girare la pala e affondare la zappa e ruotare il mandrino e bisognava quindi capirli e sostenerli che si asciugavano nelle città universitarie e tornavano con gli occhi lucidi che doveva essere una febbre che si piglia là, pure il figlio di sembrava smaniato e questo per un verso tranquillizzava e per un altro preoccupava vieppiù, perché ciascuno le febbri, e quelle di testa soprattutto, dovrebbe farsele al posto che gli compete nel mondo e non andare in giro a mescolarsi con gli altri che non ne viene mai bene, e l’infezione si sparge, e soprattutto non bisognerebbe attardarsi con quella razza da cui si proviene e invece le «professioni liberali» declinavano tutte verso il popolo, e i medici e gli avvocati e gli architetti, come se avessero un che di sdebitarsi, come se l’avesse comprato il popolo tutto quell’olio, e pure le salsicce, e così quell’ascensione s’era fermata o c’era come un elastico che portava ancora quella generazione, troppo fresca per staccarsene, al punto di partenza.
Forse un millenarismo diffuso e radicato, proprio di un paese a modo suo di forte segno e consuetudine spirituale che ha sempre mal sopportato o imprestata per poco o considerata una bizzarria quando non un’eresia la borghese laicità e la «responsabilità individuale», e che piuttosto di rassegnarsi alla cecità e al dopodomani della provvidenza di fronte agli abissi di differenza della redistribuzione di cose e redditi che mandava senza rimedio chi al paradiso e chi all’inferno in terra per quel tempo di vita che ci tocca in sorte trovava più evangelico scagliare pietre, che si sentiva senza peccato, e prendersi adesso una propria quota di felicità, apparare un po’ le cose, provvedere da sé insomma, senza più rosari e litanie.
Forse quella mescolanza di ceti e classi che accade con più frequenza da noi e non altrove dove più chiare sono le distinzioni di censo e lingua e territorio e pelle e i posti assegnati a tavola sono scritti a lettere chiare e non ci si può confondere, e mette assieme, questa mescolanza, l’alto e il basso, o innalza il basso e precipita l’alto, e addensa le cose e gli uomini quasi tutti in un punto e costituisce una massa critica potente per la sua forza di inerzia e travolgimento che sbanda e si impenna ora di qua ora di là e a volte ha rovinato il paese verso il precipizio a volte ne ha migliorato e non di poco le sue sorti nella storia, a volte l’una cosa è stata pure l’altra.
Forse l’improvviso costituirsi d’una lingua comune e di facile comprendonio in una nazione abituata a mille dialetti, uno per ogni contrada, uno per ogni targa di comune, e alla reciproca sordità di accenti troppo forti, dove un glossario d’un qualche centinaio di parole era ora sufficiente per capirsi insieme semplicemente, come al servizio di leva, nonostante sibilanti e gutturali e vocali strascicate o smozzicate perché non c’erano le dizioni precedenti di parole come «comitato», «organizzazione», «sabotaggio», «avanguardia», «violenza», e quindi si poteva solo accoglierle e innestarle, intiere nel loro significato di radice, e immacolate nella loro incontaminazione, e ci si poteva riempire la bocca ed esercitarsi a dirle e masticarle e ripeterle sempre le stesse e sempre nuove perché mai erano state dette, e poi bisognava pure farle diventare, le parole, mettersele davanti agli occhi, soffiarle fiato addosso per farle carne, e vedere cosa davvero significassero.
Forse un’insofferenza verso i padri che erano stati fiacchi e complici di un delirio e di un orrore e questa attitudine alla mimetizzazione era proseguita in un qualunquismo sordo e indifferente al mondo, un egoismo spicciolo, un quotidiano cinismo, che sembra una meta quando si è adulti ma che fa ribrezzo quando la vita è tutta davanti e il moralismo ti circonfonde d’aura; oppure un volerli riscattare che tanto avevano sofferto e sperato e s’erano battuti restando con un pugno di mosche in mano, una generosità malpagata; e se questo è vero sempre dei figli verso i padri, questo senso della loro colpa che è poi la propria innocenza, ci sono le specifiche contingenze e i giovani balilla e l’orbace e le adunate di massa e la guerra d’affrica e d’albania e grecia o l’andare in montagna e l’occupazione delle terre e delle fabbriche e l’ora X dell’insurrezione sempre rimandata e altrove c’era un impero vecchio o un impero nuovo o Auschwitz o l’Algeria o il Vietnam e insomma ciascuno ha le sue rogne ma dipende pure da come te le gratti e le piaghe che vengono, che a quel punto non sono proprio immeritate come quelle di Giobbe.
Forse un precedente ciclo di accumulazione troppo lungo senza spartizione del bottino, una ricostruzione prima e un boom dopo che avevano fatto fortune inimmaginabili, che se ne stavano tranquille, quelle di prima, affondate nel tempo e negli agi, appartate e riverite pure, e ti scappellavi se li arricchivi di più quelli già ricchi, ma ora, quelle di dopo, erano diventate selvagge e sfrontate, senza riguardi e senza rispetti, indecenti, e c’era chi le sprecava queste fortune in vite da rotocalchi e in americanate che mai s’erano viste, e la soggezione veniva meno e l’avidità veniva più, e tutto questo grano all’ammasso che si stipava prima e si dissipava ora faceva gola adesso che era visibile e si capiva pure da dove veniva, dalla fatica veniva, solo dalla fatica, e il godimento era tutto nel consumarlo, ma per quello non è che ci vuole un ingegno o un talento particolare e trasmesso nei protocolli notarili, che sono buoni tutti, e quindi era venuto il momento di dividerlo quel bottino, di partecipare alla festa, ecco, se non di restituirlo alla fatica.
Forse una consuetudine alla festa paesana e alla processione, all’esagerazione d’un giorno e al sacrificio di sempre, alle maschere alle luminarie e ai botti, ai riti, alle flagellazioni e alle resurrezioni, ai martiri e ai ladroni, alla reiterazione di concessione di grazie, alle profezie e ai santi che sembrano matti e ai matti che sembrano santi, al sacro mescolato col profano, colori di terra mal impastati, sempre sabbiosi e rabbiosi, tutto un paganesimo inestirpato che ha il suo centro di gravità, la sua grotta miracolosa nella pancia piuttosto che nell’anima o nella testa, nella pancia dove non si stilla sangue ma borbottii inconsulti, dove si è mercenari di sé e pure però rigorosi, di quel rigore assoluto che è sempre fuori luogo ma piglia piede e si fa scalzo, e uno si fa semplice per non sopportare il fardello del corpo, e quindi beato. E violento per un giorno, perché il paganesimo è violento e irridente, lazzaro e beato, di quella beatitudine della pancia, mai appagata.
Forse la deriva di timide aperture riformiste che, sotto, la pentola bolliva assai e la pressione era tanta e bisognava allentarla, ma, si sa, se dai un dito si prendono la mano e il braccio fino al gomito e anche più su, come una cancrena che avanza, e una volta che hai aperto uno spiraglio entra come uno spiffero che non lo fermi più, e allora quelli che l’avevano sempre detto che ogni cosa deve restare al suo posto e pure si erano acconciati con riserva e malvolentieri alle timide aperture riformiste adesso facevano la faccia feroce e pure le azioni che commettevano in combutta coi malacarne erano feroci assai ma invece di intimidire, quelle azioni feroci, insomma di far tornare le cose al loro posto, indignavano e ci si faceva coraggio l’un l’altro perché certo paura ce n’era con tutto quel sangue e allora si spingeva ancora per allargare di più lo spiraglio, per spalancare del tutto la porta. Per farla finita con quelli che si acconciavano malvolentieri e complottavano. E pure coi malacarne.
Forse il quadro internazionale, inesorabilmente bloccato e pure sempre impercettibilmente mosso, e pieno di figli di puttana che sono «nostri» [loro, degli uni e degli altri] e tirano fuori il peggio di sé e si fanno la guerra gli uni contro gli altri, e si finanziano e si foraggiano ferri vecchi – di testa e di coglioni – e si mettono a busta paga popolazioni intere e si progettano fantastici piani e golpe e contropiani e controgolpe, come se davvero questa provincia contasse qualcosa per loro, e se la volessero accaparrare a qualunque costo o se la volessero tenere a qualunque costo, tutta una storia di gente miserabile, una coazione a ripetere di una logica affatto endogena, dove gli uni trovano le proprie ragioni negli altri, capace solo di provocare danni, solo un pallido riflesso, specchio deformato di mostri.
Forse. Per certi versi sembra si sia configurata una situazione «sovietica»: un paese a industrializzazione alternata e con una notevole arretratezza intorno alcune aree a coscienza avanzata, e che invece di attendere il naturale compimento di un processo, battendosi per un riformismo progressivo, coglie le contraddizioni nel punto più alto, nel «piano», e compie un balzo insurrezionale senza farla mai, l’insurrezione, anzi, facendosi motore di sviluppo: la democrazia operaia produce elettrificazione; per altri versi, all’opposto, una situazione «americana» di capitalismo selvaggio, di accumulazione primitiva, di frontiera, di capitani di ventura, dove le turbine spazzavano via tutto senza riguardi e si poteva solo resistere, riformare un po’ qui e un po’ lì, a caro prezzo pure. Magari la verità sta nel mezzo: il capitalismo italiano è sempre stato un po’ manomorta e un po’ brigante, la democrazia operaia è sempre stata solo una romanticheria.
Per me resta un mistero.
A volte credo di trovarne una chiave di lettura in un’antropologia spicciola, in certe figure che si stavano modificando geneticamente, che non erano ancora una cosa e non erano più quell’altra, perché negli anelli di passaggio sta l’evoluzione, e così me le immagino, le figure, come disegni a sanguigna, un bestiario favoloso di anomali mostri a due teste, a due vite che si intrecciavano e sovrapponevano, la vita a due vite degli operai-studenti, che lavoravano molto per studiare molto, e andavano da una vita verso l’altra, o la vita a due vite degli studenti-lavoratori, che c’erano questi, e studiavano poco il giorno per lavorare poco la notte, e andavano come quelli di prima pure loro da una vita verso l’altra ma all’incontrario, o la vita a due vite dei preti-operai, che c’erano pure questi, che lavoravano molto il giorno per pregare molto la notte, o quell’altra vita a due vite degli operai che nelle feste comandate invece di pregare o di studiare facevano i contadini che erano stati e si zappavano l’orto, come una cosa cui non sapevano rinunciare neanche volendolo o una cosa che non si sa mai, e quell’altra vita a due vite ancora, di quelli che facevano gli operai che erano diventati in un posto e i manovali che erano sempre stati in un altro dove costruivano casa e riparo, e così si spaccavano la schiena due volte, e pure quell’altra, di vita, dei contadini che ora erano operai e basta, e non studiavano, non pregavano, non zappavano, non costruivano casa, ma dentro sempre quello erano rimasti, contadini, e trattavano le macchine come fossero bestie, asini erano. E poi c’erano dappertutto i fuori-sede, nelle università c’erano e nelle fabbriche e nei quartieri, come se l’Italia tutta non avesse più sede, luoghi di stabilità, punti di riferimento dove la vita scorresse tra panorami saputi e tramandati e si trovasse invece tutta proiettata nell’ignoto, tutta strapiantata, e fosse quella, del fuori-sede, una condizione provvisoria, una biologia provvisoria, una morfologia provvisoria, e allora si potevano dire e fare cose che non si sarebbero mai potute dire e fare «in sede» e che mai, quando si sarebbe infine arrivati in quella «nuova» di sede, che sarebbe stata un’età forse, un tempo più che uno spazio, si sarebbero potute più fare e dire. Dava libertà, ecco, dava potenza, quello stare fuori-sede, che era un fuori di sé, che andava colto, come una seconda occasione che la vita ti offriva, come un’occasione irripetibile, una seconda vita, che era diversa da quella che ti avevano prescritto.
E tutto questo sovrapporsi di vite in una vita, di biologie più che di biografie, creava confusione nella natura.
Chissà invece se la natura fa i salti, che si crea una crepa nell’evoluzione, e lì impazzisce e va di qua e va di là come furiosa perché non trova una forma adatta e plasma e distrugge e rimodella ed estingue e viene fuori una cosa mai vista prima e che mai si vedrà dopo, che non c’è lo stampo.
E questo è stato il fattore A.
2. A come autonomia, autonomia di classe, autonomia operaia.
L’autonomia operaia è la «coscienza enorme» del lavoro di essere prodotto del modo di produzione del capitale e quindi di non potere essere se stesso altrimenti che sviluppando al massimo le sue condizioni e di non potere al tempo stesso che esservi contro, che rifiutare se stesso, ovvero di essere contro se stesso in quanto altro da sé e per ritrovare se stesso come altro, e in questo gnommero di contraddizioni e conflitti dove la natura divenuta parassitaria tutta del capitale che non inventa, non investe e non capitaneggia ma agisce solo reattivamente che succhia il sangue e il cervello e l’anima, il lavoro si fa indifferente al processo da cui viene e non vuol più sentirne le ragioni e ascolta solo le proprie di ragioni, che sono bisogni poi, che sono interessi poi, che sono desideri poi.
Ecco, questo è quanto accaduto, il costituirsi di questa «coscienza enorme». In uno specifico tempo, gli anni Sessanta e Settanta, in uno specifico luogo, l’Italia. Che esista una relazione stretta fra il costituirsi di questa coscienza, l’autonomia operaia, e l’anomalia italiana a me sembra cosa di tutta evidenza. Li si può anche considerare come due processi distinti, indipendenti e sicuramente non sovrapponibili, ma sarebbe davvero diabolico dire che l’anomalia italiana sia dipesa tutta da altri fattori, il quadro internazionale, che so?, la politica, che so?, l’innovazione scientifica, che so?, la cultura, che so?, la produzione. Quale sia l’esatta forma della relazione combinata però non sono in grado di spiegarlo, e sulle labbra arriva tutta una locuzione o tutto un giro di parole. Come non sono in grado di spiegarne il modo, ovvero l’estensione nello spazio e nel tempo, la sua formazione, la sua fisicità. La coscienza enorme del lavoro si accumula lentamente, per sedimentazioni minime, per esperienze progressive, fino a raggiungere una massa che si rovescia poi su tutto travolgendo ogni cosa, ogni cosa illuminando? L’autonomia operaia è un sapere, qualcosa che può comunicarsi, trasmettersi da qui a lì, da questo a quello? L’autonomia operaia è soggetta come tutti i corpi del mondo a processi di entropia, a una irreversibile perdita di forza ed energia nell’espandersi? L’autonomia operaia è sottoposta a usura, un allentamento dei suoi meccanismi di fissaggio, delle sue puleggie di trasmissione, e qualcosa sbiella qua qualcosa si inceppa là, finché tutto non si tiene più e la ruggine insorge, e viene abbandonata all’archeologia? L’autonomia operaia si disperde come un gas o si contrae tutta in un punto senza massa ma con un’energia inimmaginabile pronta a riesplodere per un qualche processo che ancora non è stato scientificamente osservato e scoperto? L’autonomia operaia lascia dopo il big bang una radiazione cosmica di fondo che non è percettibile se non attraverso sofisticati strumenti capaci di andare oltre il mondo conosciuto?
Quello che so, e che ha attinenza con questo libro, è che tra l’autonomia e gli autonomi non passa alcun rapporto unico e diretto. Quel rapporto unico e diretto tra parole che passa, mettiamo, tra il diabete e i diabetici: ovvero questi sono l’esatta configurazione di quello, e studiando gli uni, e le loro caratteristiche patologiche, capisci quello e le sue diverse forme. Non esiste, in questo caso, la malattia senza il malato, la cosa senza gli attributi: i diabetici «sono» il diabete, ma questo non può dirsi degli autonomi. Che non «sono» l’autonomia. Oppure, mettiamo ancora, il rapporto tra parole che passa tra la vela e i velisti, perché è vero che la vela esiste senza i velisti e di fatto il suo senso e il suo significato ci è percepibile e osservabile anche senza immaginare che quelli ci siano, cioè essi non ne sono la precipua unica incarnazione, così come di fatto è per gli autonomi, ed è pure vero che non puoi comprendere i velisti senza fare riferimento cospicuo alla vela, ma lo stesso non può dirsi degli autonomi, perché i velisti senza la vela sarebbero propriamente un’altra cosa, mentre gli autonomi anche senza l’autonomia sarebbero sempre gli autonomi. Oppure, e finisco qui, per fare un riferimento più congruo, il rapporto fra parole che passa fra l’operaismo e gli operaisti, che è quello che si capisce più semplicemente, non foss’altro per la ricorrente presenza d’un suffisso, che rimanda a una radice lontana. Gli operaisti, cioè, somigliano ai diabetici, perché non esiste l’operaismo senza gli operaisti e studiando questi e le loro patologie capisci quello, e ci sono gli operaisti melliti [dolci assai] e gli operaisti insipidi [sciapi assai], e quindi, di sicuro, noi riscontriamo un operaismo dolce o sciapo, ma rispetto ai diabetici gli operaisti sono sempre il suffisso di un’altra sostanza. Gli autonomi invece non sono il suffisso dell’autonomia. Non sono il suffisso di nulla. L’autonomia poteva essere pure senza gli autonomi, lo è stata. Gli autonomi sono lo «scandalo» dell’autonomia di classe.
La chiave forse sta qui: l’anomalia italiana è stata più forte dell’autonomia operaia. E gli autonomi sono più pertinenti all’anomalia italiana che all’autonomia operaia. Quando il grande ciclo delle lotte di fabbrica è finito, quando la spinta di massa va esaurendosi, quando la rivoluzione è perduta, ecco, rispunta l’anomalia italiana: gli autonomi. Quando esperienze, individui, gruppi e partiti della sinistra rivoluzionaria si sono sciolti, fusi, sparpagliati, ecco gli autonomi. Che sono gli «stessi» militanti – provengono da quella stessa militanza, sono «vecchi» che incontrano ragazzi – e non sono più «quelli». Uno strascico e un annuncio, un funerale e un battesimo, un lutto e una festa. È complicata l’elaborazione di questo ambaradam qui. Irrisolta. Gli autonomi erano gli ultimi che potevano riuscirci. Quanto meno, non ci sono riusciti. Gli autonomi appartengono alla storia radicale di questo paese molto più di quanto appartengano al novecento e ai movimenti operai. In questo senso sono un prodromo, un movimento aurorale e adolescente, l’annuncio della fine del novecento, qualcosa che si capirà «ex post» nei movimenti che verranno, e pure sono una forma «antica» e ricorrente della radicalità di questo paese, qualcosa che ha radici lontane e mai sopite.
Però, gli autonomi alcune cose le avevano capite, dell’autonomia. Avevano sviluppato anche loro una «coscienza enorme».
Circoscrivo qui pochi punti che a me sembrano tra i più caratterizzanti l’esperienza degli autonomi, quello che avevano capito. Che è un ritorno al lessico dell’analisi marxista della merce e del processo di produzione, per procedere oltre. E cioè: 1] il processo di valorizzazione della merce si estende lungo tutto l’arco della giornata lavorativa sociale, assorbendo il tempo della riproduzione sociale [il tempo del non-lavoro] sotto il proprio dominio; 2] il dominio del capitale si espleta attraverso la combinazione delle attività immediatamente produttive e di quelle non produttive: è la cooperazione dei saperi la vera ricchezza sociale, ed essa è assoggettata al processo di valorizzazione; 3] la «conquista» della cooperazione sociale [ovvero il «comunismo del capitale»] spezza irrevocabilmente ogni dinamica socialista della riappropriazione, che sia del processo di produzione [e dei suoi mezzi], che sia della merce. Nello stesso tempo, è qui, nella ricchezza della cooperazione sociale, nell’antagonismo all’interno della relazione alienata della socialità, ogni possibile percorso di liberazione dal lavoro.
3. The Red Scare, la cicatrice rossa.
La presenza totemica e ingombrante del «più grande partito comunista d’occidente» è stata la questione più complessa e contraddittoria per la «coscienza enorme» del lavoro negli anni Sessanta e Settanta.
È esistita, certo, una relazione fra l’anomalia italiana e la presenza massiccia dei comunisti italiani. Ma questa presenza – ovvero, l’eredità del ruolo straordinario avuto nell’uscita dell’Italia dalla guerra, nella Resistenza, nella ricostruzione, nelle lotte per i diritti del lavoro, nella scrittura della Costituzione – non comprende completamente quella – ovvero, un ciclo di lotte sociali di durata e intensità che non hanno uguali nella storia più recente. La presenza massiccia dei comunisti – e, per inciso, l’affannoso e frenetico adoprarsi degli anticomunisti – non spiega l’anomalia italiana. Anzi, questa ha spesso sorpreso, per i suoi caratteri e le sue forme, quelli. Gli strumenti di comprensione e di governo dei fenomeni dell’anomalia italiana in possesso dei comunisti erano a volte inadeguati a volte fallaci. E lo sfilacciamento [di una relazione invece fino a quel momento solida] tra gli strumenti di comprensione e governo e i fenomeni dell’anomalia italiana si fa consistente proprio con gli anni Sessanta. C’è un primo periodo in cui i comunisti si fanno naturale serbatoio e in diversi casi anche promotori e rete di collegamento tra i fenomeni nuovi dell’anomalia. L’anomalia li cerca come interlocutori e loro cercano di trarne vantaggio. Ma la nuova composizione operaia nelle grandi fabbriche e il ’68 degli studenti della scolarizzazione di massa sono questioni emergenti e radicali che li trovano impreparati. La «filiera» delle lotte, dal partito alla società e ritorno, è saltata. La «coscienza di classe» s’è già dislocata fuori dal «partito»: l’autonomia, in fondo, è proprio questo: trattenere presso di sé la «coscienza». La modernizzazione – la sua accelerazione e gli scombussolamenti che comportava – trova impreparati i comunisti italiani. Non sono in grado di maneggiarla, governarla. Le accelerazioni li scombussolano; essi, propriamente, non sono leninisti, se del leninismo è lecito dare un’interpretazione come quella «tecnica» politica capace di imprimere non solo rallentamenti ma improvvise velocità al corso delle cose. I comunisti italiani conoscono solo la manovra del rallentamento. Ogni volta che provano a trarne profitto si vedono sbriciolare tra le mani il vantaggio: dove sarebbe dovuto regnare riconoscenza e legame per i comunisti, scoppia il putiferio dell’anomalia.
L’anomalia italiana è stata nonostante la presenza massiccia dei comunisti. Per i comunisti l’anomalia è un fenomeno di disordine e arretratezza. Pensano ancora all’Italia come a un paese di Risorgimento incompiuto e interrotto e difatti si applicano meglio proprio dove lo Stato e l’unità nazionale vanno corroborati o sono in crisi. Essi incarnano la «coscienza civile d’una nazione», hanno il senso di «ceto dirigente» d’una nazione.
È il «loro» Gramsci: «Per conquistare lo Stato occorre essere in grado di sostituire la classe dominante nelle funzioni che hanno un'importanza essenziale per il governo della società. In Italia, come in tutti i paesi capitalistici, conquistare lo Stato significa anzitutto conquistare la fabbrica, significa avere la capacità di superare i capitalisti nel governo delle forze produttive del paese». È in nuce la deriva ontologico-corporativa del compromesso storico; lo Stato deve essere salvato dagli operai che facendosi carico del piano di accumulazione devono imporre una dirittura ideologica alla classe intellettuale-politica, organizzata nei partiti. Questa impostazione è il fondo di bicchiere comune alle diverse «sfumature» comuniste: dalla concezione di Vacca – «promuovere una prospettiva di ricomposizione unitaria dei conflitti che i partiti soprattutto interpretano e mediano» –, a quella ingraiana del decentramento dello Stato attraverso il tessuto corporativo dei partiti che si fanno strumento unitario di emancipazione delle masse, a quella trontiana dell'autonomia del politico per cui la classe operaia unica interprete del potere politico batte sui tempi, anticipandolo, il capitale, nella riorganizzazione della macchina statale arretrata rispetto alle esigenze di valorizzazione del capitale. Dunque assolutamente in linea con la gramsciana «capacità di superare i capitalisti nel governo delle forze produttive del paese».
La coscienza enorme del lavoro, l’autonomia di classe, è il fattore determinante dell’anomalia italiana degli anni Sessanta e Settanta; la presenza dei comunisti italiani è un fattore relativo. E da un certo punto in poi [la «crisi» degli anni Settanta] diventa un fattore opposto e contrario. Gli anni Sessanta e Settanta possono leggersi sostanzialmente come un conflitto aperto tra l’autonomia di classe e i comunisti italiani. Un conflitto tutto «dentro» il lavoro.
Ma è proprio questo – il conflitto tutto «dentro» il lavoro, piuttosto che come piacque dire ad Asor Rosa «tra le due società» – il vero motore delle trasformazioni nel paese, la linea di condotta. Il resto – il neofascismo, i complotti, le stragi, i governi democristiani allo sbando, le ammuine di centrosinistra, la Cia, la Gladio, la razza padrona, le logge P2 – sono le forme di resistenza, le schegge impazzite di un potere sulle cose e sugli uomini di questo paese, che si sente spazzato via, che non ha più strategia, respiro, visione. Il «cuore nero» del potere è uguale dappertutto, non ha geografie localizzabili per differenze e intelligenze: manda sicari, organizza stragi, prova il contenimento con la minaccia del peggio, corrompe con fiumi di denaro, fomenta i militari. Le dinamiche del potere sono poche e obbligate. Esse non «fanno» anomalia. Il resto, il «piano» del capitale, è sullo sfondo. Tutto collassa e impazzisce. Tutto è ingovernabile. Ogni pezzo della macchina dello Stato fa da sé. I comunisti si candidano a ridare senso unitario allo Stato. È la loro vocazione.
Il passaggio determinante, nella consapevolezza dei comunisti italiani, è quello della «autonomia del politico». L’«egemonia», la «società civile» sono ormai paccottiglia – l’anomalia italiana è ingovernabile.
L’autonomia del politico vuole mettere in moto la macchina di riorganizzazione dello Stato: nella sfera politica, afferma Tronti, «c'è un difetto di razionalizzazione [..] c'è un'assenza di imprenditorialità [..] non c'è un piano dello Stato così come c'è malgrado tutto [..] un piano del capitale. C'è insomma un'insufficienza di capitalismo, e, più precisamente di grande capitalismo, nello Stato moderno».
Lo strappo dalla coscienza enorme del lavoro è compiuto fino in fondo. L’autonomia del politico, «scheggia impazzita» dell’autonomia di classe, vuole ricondurre a ordine l’anomalia italiana.
Gli autonomi «impersonificano» questo conflitto. Gli autonomi sono la forma politica della coscienza di questo conflitto ormai irresolubile. La forma dello scontro. Gli autonomi sono apertamente contro i comunisti. O, come piace dire ai comunisti, «oggettivamente» anticomunisti. Non c’è via d’uscita da quella porta stretta: il conflitto diventa evidente, politico, pubblico. E i comunisti italiani si mettono all’opera per l’annichilimento – con qualunque mezzo e fino all’ultimo uomo – dell’autonomia operaia. Qualcuno, per pudore, si trattenne, i più vi indulsero. L’autonomia del politico prevede l’assenza di gravità, ma la forza di gravità esercitata dall’autonomia operaia era un eccessivo «fattore di disturbo».
Non c’era, forse, partita. Ma questa è stata la partita. Da piazza Statuto alla cacciata di Lama. Ovvero, il periodo in cui più fecondo è stato il «sistema» italiano.
E forse questa è in fondo l’anomalia italiana: lo scontro dentro la classe promuove innovazione. Il capitale ha «vissuto», parassitariamente, di questo scontro. Il capitale si è riorganizzato politicamente sfruttando la guerra dentro la classe, dentro il lavoro. A partire dalla «crisi», dal 1973. L’anomalia italiana è un movimento di sinistra contro la sinistra. Il più forte movimento di sinistra contro il più forte partito comunista. O, per dirla altrimenti, un movimento comunista contro la sinistra. Un movimento comunista contro i comunisti. Un movimento di sinistra anticomunista.
La leva con cui i comunisti italiani fecero guerra all’autonomia operaia fu la «lotta al terrorismo». Era il terreno, politico, statale, d’apparati, complottardo, in cui più forte e adusa era la capacità comunista – nelle fabbriche avevano perso, nelle strade avevano perso – e più debole e impropria l’autonomia di classe.
4. Le pistole, i fucili.
Il vero scandalo, la vera anomalia dell’autonomia operaia è la violenza.
Per l’autonomia operaia la violenza è una questione relativa, una variabile dipendente, un esercizio momentaneo, una possibilità, una risorsa.
Per gli autonomi la violenza è una questione assoluta, un principio indipendente, una attività continua, una occasione, un bisogno.
Quando il luogo proprio dell’autonomia operaia, la fabbrica, va in crisi, rimane la piazza. E mentre in fabbrica i comportamenti della lotta sono flessibili, muovendosi su un arco di gradualità e di scelte, legate a criteri dati dalla consapevolezza della «forza», dello stato della forza e dello scontro, in piazza la scelta è obbligata, «scriteriata»: o si è pacifici o si è violenti.
Gi autonomi furono violenti. Gli autonomi «furono» la piazza. Gli autonomi resero violenta la piazza. «Quella» piazza in quel tempo. È dalla violenza della piazza che viene la violenza degli autonomi. La piazza è il luogo proprio della politica di quel tempo. Dello scontro di classe di quel tempo. Non lo è più la fabbrica: la fabbrica non è più il luogo dove si forma la coscienza enorme del lavoro, non è più il luogo dello scontro. È in piazza che si gioca la politica. Non c’è un altro «spazio pubblico». Gli autonomi giocano la loro politica in piazza. Dall’altra parte, dalla parte opposta, ci sono le autoblindo. Le autoblindo presidiano le piazze.
È la stessa piazza dei grandi cortei operai, delle manifestazioni democratiche. È la stessa piazza della sinistra rivoluzionaria extraparlamentare, e non è più la stessa. La piazza dell’autonomia è proprio un’altra cosa. Non c’è alcun parallelo.
Dipende dall’armamento.
Gli autonomi vanno in piazza armati. Naturalmente armati. E questo è uno scandalo. Questa è l’anomalia. Una cosa mai vista prima e che mai si vedrà dopo. Che non c’è lo stampo.
Nessuna storia dei movimenti operai vi parlerà di una manifestazione di piazza armata.
Le armi si nascondevano, si inguattavano, si accumulavano, si oliavano, ma non si tiravano fuori in piazza. Si accumulavano e si tiravano fuori per la guerra, la resistenza, la liberazione nazionale, la presa del Palazzo, non per le manifestazioni. Per le parate, non per le manifestazioni. Le manifestazioni operaie sono «per principio» brutalizzate, calpestate, cannoneggiate, sparate ad altezza d’uomo. Quando i movimenti operai derogano da questa «legge» della storia, quando si armano per lottare è solo «dopo» una guerra, solo dopo che una generazione ha imparato l’uso delle armi, ha familiarizzato con le armi, si è addestrata all’esercizio militare. Così nel biennio rosso, così nel ’48. Ma gli autonomi non hanno pratica militare e scuola di guerra, non sanno per esperienza la battaglia e la strategia, non hanno la più pallida idea di cosa sia un esercito e lo scontro fra forze in campo. Gli autonomi hanno solo le armi.
È l’«antica» e ricorrente storia dell’anomalia italiana che vi racconterà di armi in piazza, portate naturalmente, non quella dei movimenti operai. È l’«antica» e ricorrente storia italiana dei movimenti insurrezionali che vi racconterà di armi in piazza.
Tra la crisi della fabbrica e l’esplodere della violenza di piazza degli autonomi la relazione è stretta. La fabbrica – il lavoro operaio – è la «forza» trattenuta, allusiva, strategia di classe, governo: nella fabbrica la forza operaia è data dalla «concentrazione». La piazza è dispersiva, è fatta di vie, vicoli, strade, corsi, slarghi. La forza della fabbrica è direttamente politica, ed è direttamente politica proprio perché è mediata e lenta: non deve applicarsi, basta sia in potenza. La violenza della piazza è immediata, non ha allusività, è qui e ora, rapida. Si consuma tutta nell’esprimersi.
La piazza dell’autonomia è proprio un’altra cosa. Non c’è alcun parallelo neanche con la piazza della sinistra extraparlamentare. La filiera delle storie individuali – dai servizi d’ordine alla violenza di piazza – non spiega proprio nulla. E non spiega nulla neanche il passaggio, dove ci fu, dalla violenza di piazza al terrorismo. Non più di quanto una biografia possa spiegare un movimento di massa. Neppure tante biografie fanno un movimento di massa. I servizi d’ordine nascono per «controllare» la piazza, le manifestazioni. Gli autonomi stanno lì ad incendiarla, la piazza. Gli autonomi si scontrano subito con i servizi d’ordine, un tramezzo, una paratia. I servizi d’ordine tirano fuori le loro spranghe, i loro bastoni; gli autonomi, le pistole.
Le biografie, semmai, sono un indizio. E lo sono proprio nella parte più «tecnica». Quella della descrizione della quantità e della qualità dell’armamento. Gli autonomi andavano con i fucili dove sarebbe bastata una pistola, andavano con le pistole dove sarebbero stati necessari i fucili. I terroristi, quelli sì, studiavano bene le armi, non facevano altro.
Lo spirito del tempo della seconda metà degli anni Settanta, quello degli autonomi, sta tutto lì, nell’armamento.
Ma rimane fuori – fino a esserne la parte preponderante – una violenza diffusa, impulsiva e compulsiva, «folle», sregolata, che era il «cuore» degli autonomi. Era il «cuore» dell’anomalia italiana.
Gli assalti alle armerie – che ci furono e numerosi – sono come gli assalti ai forni: questi, come quelli, non appartengono alla storia dei movimenti operai, ma infoltiscono la storia dell’anomalia italiana.
Proprio sulla violenza gli autonomi persero. Persero militarmente. Persero quando si avvitarono nello scontro militare, quando divennero combattenti.
Politicamente non potevano perdere, perché quella violenza non era «politica». Quella violenza era lo «stato nascente» di una nuova classe del lavoro. Ora è qui.
Roma, gennaio 2007