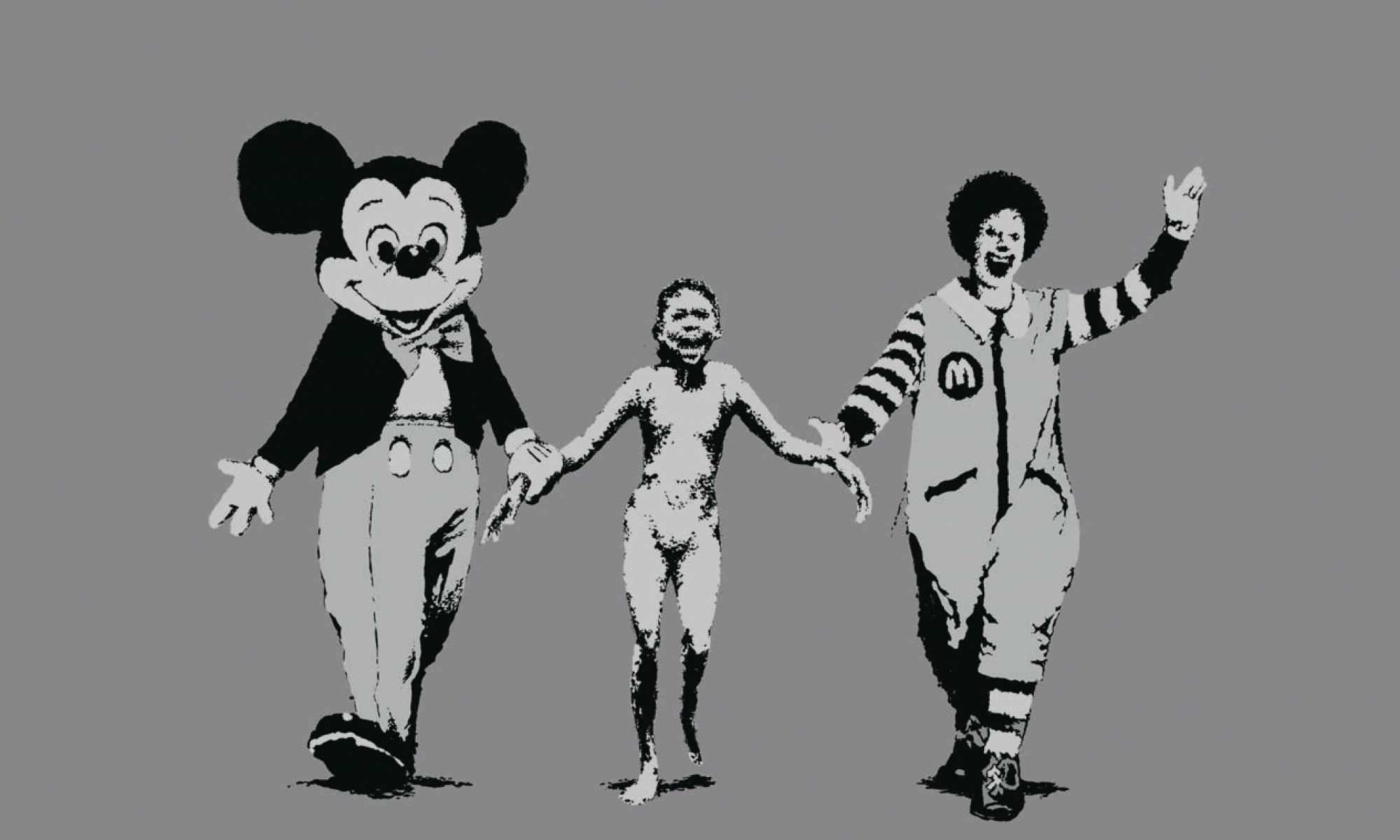In questi giorni è morto uno dei grandi musicisti del secolo scorso, Max Roach, eccelso batterista afroamericano. Aveva 83, e da che ne aveva 21 rivoluzionò il suonare il suo strumento, in particolar modo nell’ambito del jazz.
Ma questo sarebbe la meno, o almeno, sarebbe "semplicemente" l’ennesima morte di un grande jazzista, in un’epoca che ormai vede in questo ambito in cui i grandi ormai sono tutti abbondantemente sopra i 60 anni.
Ma qui stiamo parlando non solo di un grande, grandissimo musicista, che ha rivoluzionato il suono del suo strumento nella musica contemporanea, ma anche di un uomo che ha lottato per la sua gente, e per la libertà in generale, e che queste lotte ha pagato, anche pesantemente.
Per questo voglio ricordarlo, con un bel articolo di Luigi Onori:
Max Roach, il ritmo libero dell’orgoglio «black»
Il batterista e compositore, uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi, è morto ieri all’età di 83 anni. La sua musica è stata insieme melodia e percussione, Africa e America, fantasia e coraggio politico. Un artista sempre all’avanguardia, dalla rivoluzione del be bop negli anni ’40 al jazz come unica forma di democrazia realizzata, che ha spesso pagato di persona il suo impegno contro l’ingiustizia e il razzismo
Luigi Onori
Sul palco c’è un cono di luce e un uomo, solo, con la sua batteria. Piatti, tamburi, bacchette dipingono una musica che è, insieme, melodia e ritmo, composizione e improvvisazione, Africa e America, orgoglio black e coraggio politico. Quest’uomo è Max Roach, uno dei più grandi jazzisti mai esistiti: il cono di luce che ha illuminato tante sue performance si è spento, la sua vita si è interrotta ieri sera nella sua casa di Brooklyn dopo una lunga malattia a cui il batterista ha resistito caparbiamente.
Roach è stato una tra le figure più carismatiche e limpide dell’universo sonoro e culturale afroamericano, un musicista sempre all’avanguardia dalle eccelse qualità tecniche che ha saputo unire al talento lucidità politica, fierezza e coraggio. Più di una volta – schieratosi a fianco della lotta per i diritti civili dei neri e ovunque ci fosse da battersi contro ingiustizia e razzismo – ha pagato di persona. Nel 1960 nessuna etichetta americana volle pubblicare il suo incendiario album We Insist: Freedom Now Suite!, nessuno volle editare quei solchi in cui si parlava di schiavismo, segregazione, apartheid, freedom riders con poesia a coscienza politica. Solo l’amico Charles Mingus pubblicò l’album per la sua label indipendente (la Candid): Roach per parecchio tempo trovò ingaggi a fatica e quel disco fu bandito dalla Repubblica Sudafricana fino al crollo del regime segregazionista (vi incise Tears for Johannesburg).
Le sue bacchette, le sue capacità compositive e di band-leader, la sua incredibile fantasia ritmica, il suo stile solistico unico hanno sempre saputo trovarsi al punto giusto all’appuntamento con la storia del jazz. Mentre negli anni ’40 studiava percussioni classiche a New York, il giovane Max (nato in North Carolina nel 1923) era tra i batteristi più quotati nel giro underground dei boppers. Insieme a Kenny Clarke rivoluzionò la concezione ritmica e il ruolo dei batteristi nei piccoli gruppi guidati da Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Bud Powell. Il tempo-base non veniva più scandito dalla grancassa o dal charleston ma dal piatto ride suonato con la mano destra. Questa scansione in legato creava un beat elastico sui cui la musica decollava mentre il batterista poteva marcare con possenti e imprevedibili off-beats il suo incedere, utilizzando gli altri pezzi della batteria. Basta ascoltare la registrazione di Salt Peanuts dal vivo al Royal Roost del 1948 per rendersi conto di questa rivoluzione.
La batteria nella dimensione inventata da Roach (e Clarke) era strumento tra gli strumenti e generava una tensione poliritmica impressionante. Max, inoltre, aveva una particolare attenzione per l’accordatura dello strumento: tamburi e piatti percossi generavano suoni con altezze ben determinate e in questo modo era possibile costruire dei soli che erano sia ritmici che melodici. Tale tecnica porterà negli anni ’50 (e nei decenni successivi) all’incisione di brani per sola batteria come il celeberrimo The Drum Also Waltzes.
Negli anni ’70 e ’80 Roach darà vita a una formazione di soli strumenti a percussione – M’Boom Re Percussion – mandando avanti l’utopia di una musica creata utilizzando marimbe, vibrafoni, timpani, congas…
Tra i protagonisti del bebop, il batterista sarà sulla breccia anche nel cosiddetto hard-bop degli anni ’50, costituendo un quintetto codiretto con il trombettista Clifford Brown che farà scuola, insieme ai Jazz Messengers. Max Roach, nello stesso decennio, sarà spesso al fianco di Sonny Rollins e con il saxophone colossus inciderà nel 1958 la Freedom Suite, un’estesa e avventurosa composizione realizzata in trio con Oscar Pettiford.
Sul finire dei Cinquanta la situazione politica si surriscalda, il movimento per i diritti civili avanza e molti jazzisti lo appoggiano, da Mingus a Miles Davis. Roach insieme alla moglie – la cantante e attrice Abbey Lincoln (era anche in Mo’ Better Blues di Spike lee) – e al poeta Oscar Brown jr stava lavorando a un album per il centenario della fine della schiavitù (1963) ma gli eventi precipitarono e nacque la già citata Freedom Now Suite cui parteciparono, tra gli altri, l’anziano sassofonista Coleman Hawkins (uno dei padri del sassofono) e il giovane trombettista Booker Little. In quell’album Driva Man, con il suo angoscioso 5/4, ricostruiva la terribile condizione di paura e dipendenza della schiavitù, grazie anche alla voce ispirata e straziante della Lincoln; il trittico per batteria e canto che si ascolta ancora nella Freedom Now Suite è una pagina paragonabile al romanzo Amatissima di Toni Morrison per intensità e dolore, come All Africa anticipa, e di molto, Amistad di Steven Spielberg.
Gli anni ’60 furono davvero intensi per il batterista che trovò spazio presso la neonata etichetta Impulse in un disco eccellente come Percussion Bitter Sweet in cui il suo gruppo si allarga alla presenza di Eric Dolphy. Tempi dispari, riferimenti al Sudafrica e a Marcus Garvey, arrangiamenti d’impatto, una costante ispirazione rendono quest’album uno dei suoi migliori, senza contare Money Jungle inciso nel 1963 per la Blue Note con Duke Ellington e Charles Mingus (ascoltare il delicato incanto di Fleurette Africane e la versione africanista di Caravan).
Al di là di date e collaborazioni, di incisioni e apparizioni nei festival (sempre più numerose, soprattutto in Europa) non bisogna dimenticare la capacità che Roach ebbe costantemente di confrontarsi, misurarsi, incontrarsi con le nuove generazioni. Quando negli anni ’70 esplose il fenomeno del jazz di Chicago, il batterista non esitò un momento a suonare e a registrare con uno degli uomini simbolo di quella corrente, il polistrumentista Anthony Braxton. Birth and Re-Birth del 1978 (primo album di un’etichetta italiana, la Black Saint, che avrebbe lungamente fatto parlare di sé) è un empatetico duo tra le percussioni di Max Roach e le ance di Braxton, un manifesto intergenerazionale di improvvisazione tanto radicale quanto comunicativa. Altro elemento importante e costante nella carriera del batterista la sua propensione a incrociare la propria musica con altre forme espressive: danza, rap, arti visive… E poi la disponibilità agli incontri che diedero vita a concerti e album memorabili, come quello con Cecil Taylor, sempre seguendo il filo rosso di una rivoluzione vissuta al fianco di Charlie Parker, sempre in prima linea contro il razzismo e le ingiustizie.
Intervistato nel 1994 da Francis Marmande per Jazz Magazine Roach affermò: «Ritengo che la musica che abbiamo inventato (il jazz) – e sto lavorando su questo concetto insieme a T.Morrison e Amiri Baraka – sia la sola democrazia realizzata, la sola democrazia fondata su una comunità di musicisti e un progetto collettivo, in un mondo dove non conosco vere democrazie».
Ora la sua voce e la sua batteria tacciono: molto hanno insegnato a chiunque ami la musica e la libertà.