E ritorniamoci, su sta cosa, che mi intrippa in questi giorni.
Domenica è uscito il famoso inserto de "il manifesto" su "Operai e capitale" di Tronti, con tutta una serie di articoli di vari ex e neo operaisti (per questa settimana si può trovare qui). Nulla di nuovo sotto il sole: Tronti dice che l'operismo "vero" è quello fino a "Classe operaia", che poi diventa altro (estremismo? terrorismo?) e gli operaisti non capiscono che, a quel punto, il sistema andava cambiato dall'interno tornando al PCI (UHAHAHAHAHAHAHAHAH!); c'è chi come Rieser che spara mazzatte a manca e a manca, attaccando gli stessi di cui Tronti e vabbé; ci sono altri, invece, che fanno esattamente il contrario, esaltando chi viene demonizzato dai noti sopra, arrivando all'apologia della "moltitudine" (mah…).
Insomma, la solita fuffa, non fosse per il meraviglioso Sergio Bologna. Ecco il suo, come al solito straordinario, intervento. E non ci stupisce che si legga così poco, nel nostro paese (di sicuro non all'estero), questo splendido compagno.
il manifesto, 12 Novembre 2006, pag. III dell'inserto sull'operaismo.
Tutte le location di un anniversario
L'utopia occidentale di «Operai e capitale» alla prova del presente, fra università affollate, call center, fabbriche cinesi, co-co-co che spediscono curricula, biologhe russe che fanno le badanti.
Sergio Bologna
Dove lo festeggiamo questo anniversario? In qualche aula universitaria stipata di reduci, baroni,mutilati, vedove, traditori, rincoglioniti, dottorandi? Oppure in qualche spazioso edificio industriale dismesso, ristrutturato con arte da architetti di grido, oggi show room di griffe nostrane, per l'occasione prestato allo sponsor, lieto di officiare l'ennesimo funerale della classe operaia? Preferirei altre location. In un call center, per esempio, là dove è richiesta ormai la laurea in lettere (o in scienze della comunicazione) per avere un posto. Oppure a Shanghai, dove di domenica Ronzolon di fu Giuseppe da Montebelluna addestra cinesi alle macchine utensili italiane. Oppure a Milano, dove l'ex co.co.co. spara curricula a tutto spiano dalla sua mansarda, sperando in un colloquio dove gli diranno «Ha passato i quaranta? Ma che cazzo pretende?».Oppure alla Granetti& Figli, arredi per esterni, dove il socio di private equity ha pronto un piano di ristrutturazione che caccia sì un po' di gente ma porta l'ebit a 2,7. Oppure in un normalissimo appartamento middle class, dove una biologa russa rifà i letti, lava i pavimenti ma spunta pur sempre una paga oraria migliore dei figli del padrone di casa, uno praticante presso un avvocato di grido e l'altra freelance per riviste di moda.
Ricorderei questo anniversario in mezzo al lavoro dei giovani d'oggi. Con il rischio, certamente, di far apparire il linguaggio di Operai e capitale un idioma incomprensibile, ma sempremeglio correre questo rischio, sottoponendo il testo alla prova del presente, piuttosto che vederlo imbalsamato in una teca portareliquie.
Fu la prima grande novità che Operai e capitale introdusse nella cultura degli anni Sessanta: dimostrare che era ancora possibile costruire un pensiero. Là dove imperavano schemi ideologici, retaggio delle dispute dell'Internazionale, Tronti rimetteva in gioco il coraggio del pensiero fondatore; là dove si cucinavano glosse alle scritture di Marx, Tronti recuperava il senso di una reinterpretazione che diventava sistema. Un sistema chiuso, coerente, costrittivo, assertorio, esposto con un pizzico di enfasi messianica, che rompeva il tran tran del dibattito quotidiano, del chiacchiericcio, spezzava gli indugi dell'empiria. Tronti ridiede cittadinanza ai visionari, a chi aveva bisogno in quel momento di un'utopia occidentale, soggiogati come erano tutti dalle narrazioni rivoluzionarie che venivano dal Maghreb, dall'Asia, dall'America Latina. E proprio perché si trattava di un sistema di pensiero, infondeva certezze a quelli in cui la crisi del comunismo, iniziata con la rivolta operaia di Berlino e poi con la rivolta ungherese del '56, provocava sconcerto e smarrimento.
Il punto critico, si è detto, stava nel rapporto tra astrazione e ricerca empirica. Operai e capitale non nasce dal cervello di un intellettuale singolo ma dalla passione di chi voleva capire che razza di cambiamento era avvenuto in quello specifico mondo del lavoro che è la grande fabbrica; nasce dalla voglia d'interrogarsi e di comunicare di centinaia di operai, nasce dall'impazienza di militanti di base del Pci, del Psi, della Cgil, di anarchici, trotskysti, internazionalisti, cioè di un personale politico preesistente, stufo di essere congelato, ibernato dall'agonia del comunismo, di cui allora si vedevano i primi sintomi e che ancora, maledizione, dopo quarant'anni appesta l'aria. Mario Tronti diede uno strumento teorico a una parte di questo personale politico, riuscì a trovare una sintesi alle migliaia di spunti che l'esperienza di ogni giorno, il contatto con una classe operaia che si stava risvegliando, consentiva di trasmettere.
Panzieri lo aveva portato ai Quaderni Rossi, Negri lo spingerà in Classe Operaia, ma nel 1966, quando il libro uscì, lui stava già tornando al capezzale del comunismo per provare un nuovo tipo di flebo.
Il rapporto con la ricerca di base, con l'approccio «sociologico», era complesso e non a caso produsse lacerazioni. Non perché gli uni erano «concreti » o «realisti» e gli altri erano «astratti». Ma perché c'erano da smaltire cinquant'anni di uno schema mentale che così recitava: prima viene il capitale, procura lemacchine, recluta la manodopera, poi si consolida la struttura e la mano d'opera diventa forza lavoro, poi l'azione del partito e del sindacato la farà diventare classe operaia, soggetto politico ed economico insieme.
Operai e capitale, Bibbia di quello che verrà chiamato l'«operaismo italiano», rovescia la sequenza: prima viene la classe operaia come soggetto politico antagonista (bisogna «pensarla» così), poi viene tutto il resto, piano del capitale, anarchia monetaria, ordine politico e via dicendo.
Pertanto l'operaismo italiano, amio avviso, rompe con la tradizione comunista, è il primomovimento postcomunista. Purtroppo molti dei suoi protagonisti si misero in testa invece di essere loro i «veri» comunisti.
In qualche superstite è rimasta l'antica voglia di capire perché il lavoro, invece di seguire la profezia operaista che lo vedeva unificarsi in un blocco sociale temibile, si è andato disgregando e atomizzando (secondo l'ultimo rapporto annuale Istat, il 46,6% degli italiani lavora in cosiddette «microimprese » che altro non sono, a volerle chiamarecon il loro veronome, che lavoratori autonomi con qualche dipendente, dato che la loro dimensione media è di 2,7 addetti). Quei superstiti hanno lavorato per circa trent'anni, brancolando in un buio teorico, per capire dove stava andando il lavoro. Non dovettero cercare lontano, seguirono semplicemente le vicende umane degli operai coinvolti nelle lotte dell'autunno caldo e degli anni successivi, poi quelle dei loro o dei propri figli. Dopo trent'anni di lavoro un quadro del cosiddetto «postfordismo» erano in grado di offrirlo, le loro analisi coincidevano perfettamente con le ricerche di mezzo mondo, le migliori di mano femminile. Poteva essere una base per costruire politiche del lavoro in grado di ristabilire alcuni squilibri che ormai fanno orrore anche ai liberali onesti.
E invece si trovano di nuovo messi al bando, i loro trent'anni di lavoro azzerati da un governo che doveva essere amico, con alcuni che pensano di riprodurre forza lavoro per decreto amministrativo (nella tradizione comunista c'era anche chi lo faceva deportando), altri che sfoderano un grottesco «neo operaismo» rimettendo al centro il contratto di lavoro a tempo indeterminato (quasi fosse un pallone da rimettere al centro dopo il gol), altri ancora che pensano di combattere il lavoro atipico peggiorando le condizioni di chi è costretto ad esercitarlo. Sono tutti in qualche modo figli della tradizione comunista. E proprio per questo è così bello, gratificante, essere stati «operaisti», estranei a quella tradizione.
A mio parere, Operai e capitale è ancora un testo che mal si concilia con la sinistra italiana, non solo di oggi ma anche di ieri. Furono emessi nei suoi confronti giudizi sprezzanti: è un testo di lirica (Tronti novello Petrarca e la classe operaia nelle vesti di Laura). Fu vituperato come apologia del capitale, per la tesi che «le lotte operaie producono sviluppo capitalistico».
Ma non andò così lontano dal vero, se guardiamo per esempio alla vicenda Fiat. Scossa dal 1969 al 1980 da una conflittualità permanente, assediata da attentati e gambizzazioni, la Fiat ne esce più fortediprima, con unlivello tecnologico che non ha pari nelmondo. Dal 1980 al 2002 gode di una pace sociale assoluta, esercita un potere incontrastato nella società, e ne esce sull'orlo del fallimento.
Sottoposto alla prova del presente, Operai e capitale ha ancora qualcosa da insegnare.
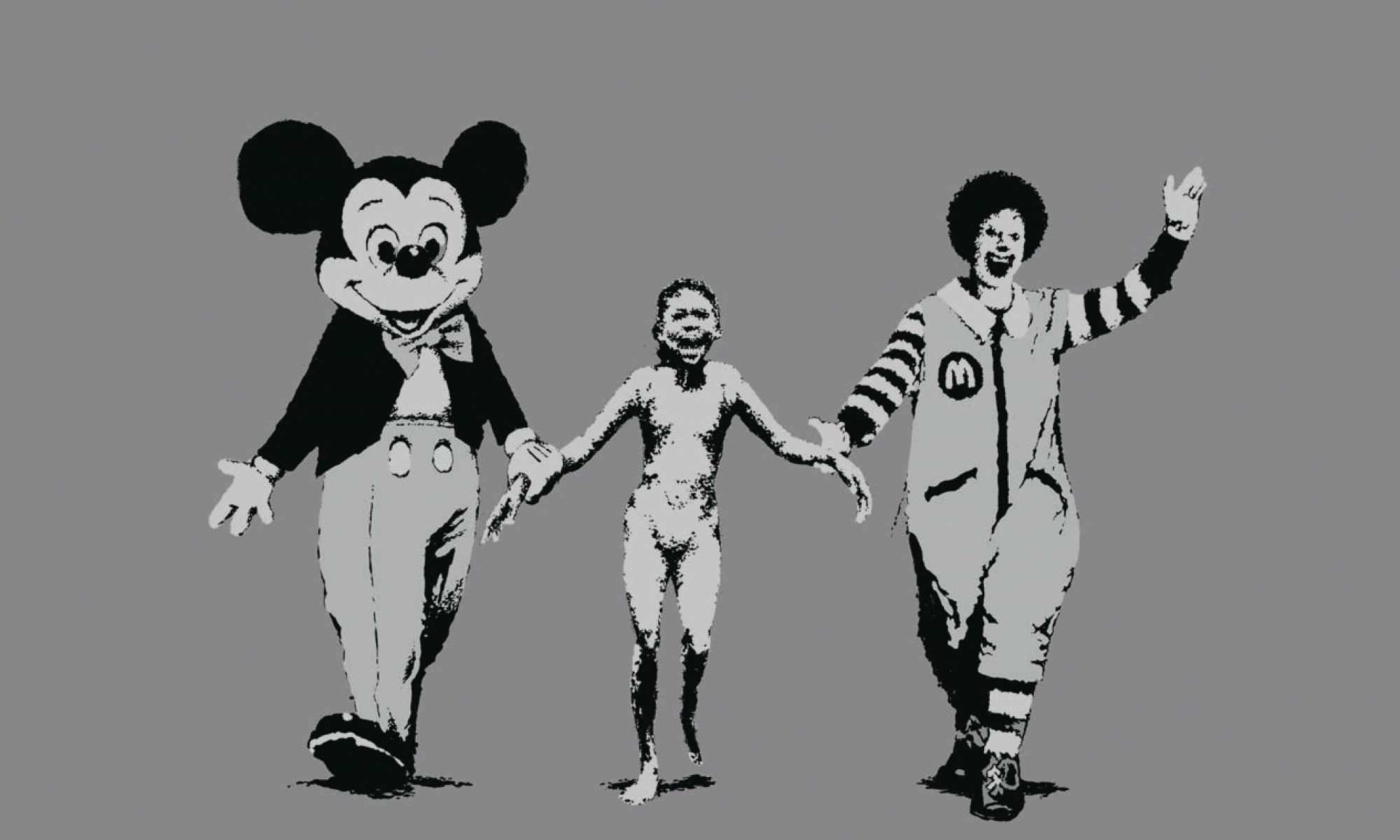

Ero un ragazzino e ricordo, ad un convegno fiorentino, Sergio Bologna che era seduto, come relatore, tra il “pubblico”. Toccò a lui parlare: andò al tavolo dei relatori, fece l’intervento, e ritornò a sedere in mezzo a noi. Non so se fu un vezzo, ma non lo credo proprio. Compagno vero e studioso pratico, da cui molto imparare. Grazie anche per questo.