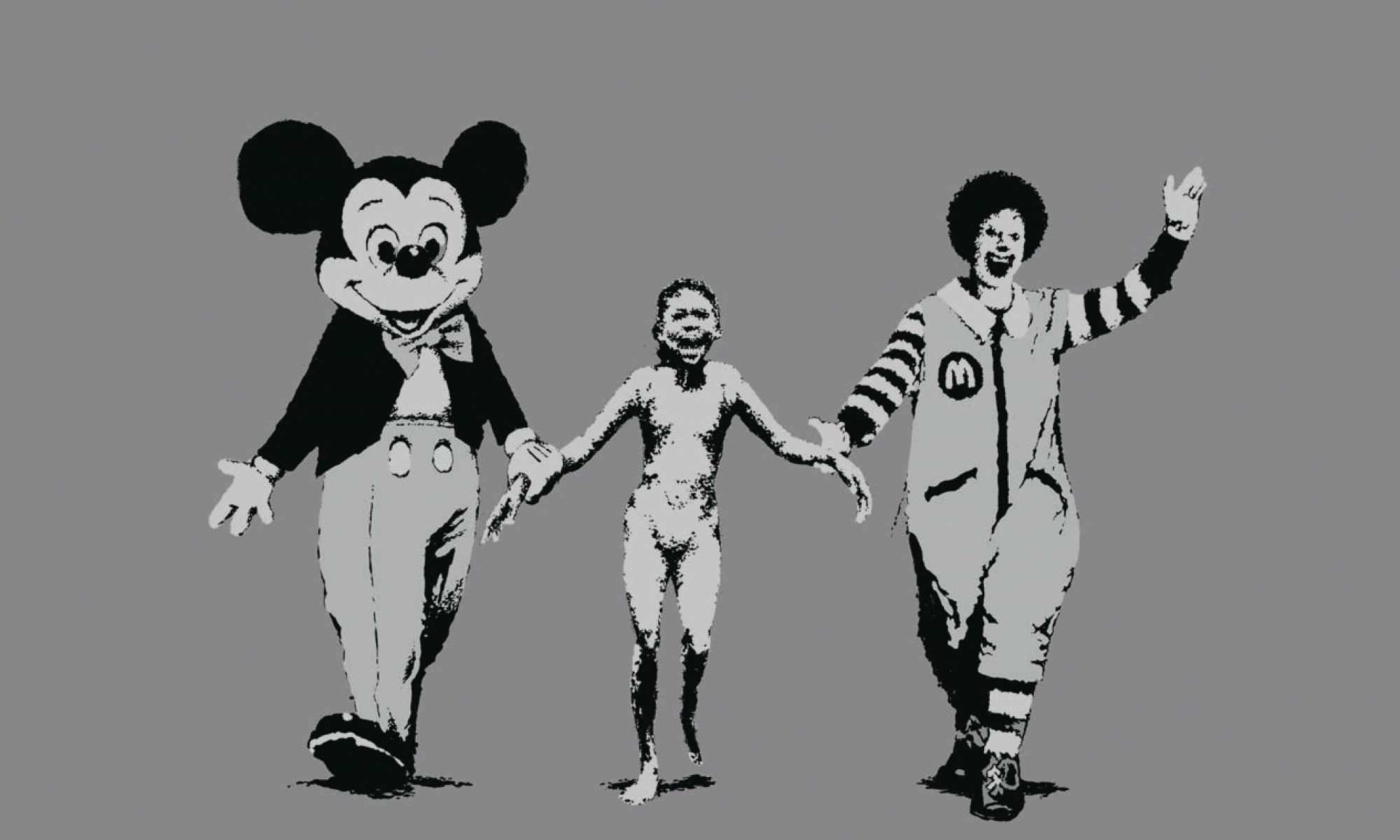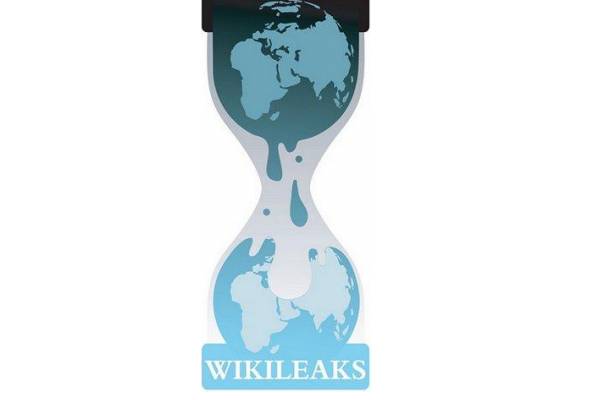Sono vent’anni proprio in questi giorni, e l’anniversario meriterebbe una riflessione, magari collettiva, orizzontale, franca, in modo da far riemergere un dibattito che è stato stroncato dalle pallottole di Piazza Alimonda, dalle torture della Diaz e di Bolzaneto e poi sotterrato con le “Torri Gemelle”.
Noi ci abbiamo provato, e con noi intendo quell@ che allora provarono a fare “Un altro mondo possibile”, non nell’ottica del “Sol dell’Avvenire”, ma qui e subito, praticando l’orizzontalità nel quotidiano, con gli hackmeeting, gli hacklab, Autistici/Inventati e Indymedia.
I primi a muoversi sono stat@ quell@ di “Supporto Legale” con una serie di pubblicazioni e un documentario che, tra gli altri appuntamenti, sarà presentato il 21 luglio proprio a Genova.
Buoni secondi sono arrivati una manciata di ex indyan@ che hanno pensato bene di scrivere in un libro corale una possibile storia di Indymedia in Italia:
https://edizionialegre.it/product/millennium-bug/
Una storia corale nel senso che il libro è costruito su una lunga serie di interviste ad attivist@ di Indy, in cui si racconta genesi, nascita, sviluppo ed infine morte dell’allora famoso network di in/formazione libera, autonoma ed indypendente.
Corale perché quella di Indymedia è stata veramente una storia bella, fatta in gran parte da giovani che, allora, avevano tra i 20 e i 25 anni (a parte una piccola ed ininfluente parte di anzian@, che non ruppero poi troppo le gonadi… almeno spero!) e che grazie al “metodo del consenso” e al loro essere interni ai “movimenti noglobal” riuscirono, per un lustro, a mettere sotto sopra non solo il mondo ormai stagnante della politica “di movimento”, ma anche tutto il mondo dei massmedia mainstream.
L’idea di fondo è semplice: sono passati vent’anni, ormai è evidente che avevamo ragione (ormai lo dicono tutti, vedi a mo’ di esempio https://www.huffingtonpost.it/entry/le-ragioni-inascoltate-del-popolo-di-genova-20-anni-dopo_it_60e31c60e4b03f72964d1073?utm_hp_ref=it-homepage), proprio per questo ci hanno massacrato, perché per la prima volta dopo trent’anni c’era un movimento internazionale e meticcio, a mettere i bastoni tra le ruote di lor signori, allora proviamo a lasciar memoria di quella vicenda e di quegli anni e, soprattutto, di quel metodo e di quelle ragioni.
Ovviamente quelli sopra sono solo due dei tantissimi interventi e libri che si occuperanno del ventennale di “Genova 2001”: è uscito di tutto, ma veramente di tutto, compreso un incredibile libro di uno sbirro che, per torbidi motivi, ha pensato bene – amplificato da buona parte della stampa “progressista” – di buttare ancora un po’ di fango su quei giorni e sulla morte di Carlo: gli sciacalli (e gli utili idioti) non si smentiscono mai.
Oggi leggo che la manifesto libri ha pubblicato o sta per pubblicare un libro sulla vicenda di Genova 2001. Evviva, ho pensato, loro c’erano, erano al Media Center con noi, in quei giorni, hanno provato a raccontare quello che veramente è accaduto, sicuramente hanno cose interessanti da dire. Su faccialibro, infatti, si può leggere:
“sapete tutte/i cosa accadde nei giorni del #G8 di #Genova2001.
Sono passati vent’anni. Noi eravamo lì dallo stadio #Carlini alla #Diaz. In mezzo #PiazzaAlimonda e #Bolzaneto.
L’AGGUATO
GENOVA 2001-2021
manifestolibri
pubblica le testimonianze di chi era lì in quelle 4 giornate in cui lo Stato sospese i #diritti #diritticivili e #dirittiumani che pubblicammo sul #LibroBiancoDeiFattiDiGenova insieme a tutte le testate della sinistra (#Unita ’ , #Liberazione, il manifesto Manifestolibri, #Carta) delle quali siamo gli ultimi sopravvissuti.
Con una lettura storiografica di Marco Grispigni e il racconto sui media e su #Indymedia di Anna Pizzo
Per #CarloGiuliani
GENOVA‘01 VENT’ANNI DOPO: UN ALTRO MONDO E’ NECESSARIO”
Quando leggo il nome di Anna Pizzo un sorriso ed un filo di malinconia increspano il mio viso.
Per chi non lo ricordasse, Anna Pizzo e Pierluigi “Gigi” Sullo erano, nel 2001, i fondatori di uno dei tanti spinoff del Manifesto, “Carta”, settimanale nato come “costola” del noto quotidiano comunista e animatori dei “Cantieri sociali”, progetto politico che provava a diffondere nei territori italioti quelli che, dopo Genova, diventeranno i “Social Forum”, sorta di assemblee territoriali che avrebbero dovuto portare le tematiche e le lotte “noglobal” ovunque (sintetizzo, che non ho voglia di raccontare tutto per bene. Cercate sull’internet se volete approfondire). Scopo più che nobile, non fosse che il metodo utilizzato non fosse esattamente orizzontale.
È grazie a loro, infatti, che ho conosciuto quelli che poi sarebbero diventati miei grandi amici – Davide e franchitiello, solo per dirne due – perché in quel giugno (mi pare) 2001 , in una Siena mai come allora attiva e vivace, piena di collettivi, iniziative, occupazioni, lotte, manifestazioni, assemblee e riunioni, un bel giorno ci svegliamo e veniamo a scoprire, leggendolo sul giornale, che proprio a Siena si sarebbe aperto un “Cantiere sociale” e che tutta la cittadinanza festosa e festante era caldamente invitata a partecipare, per portare il movimento anche nella città del Palio.
Fottendosene allegramente di un decennio buono di movimento, che pur piccolo che fosse, a Siena in quegli anni aveva fatto tante cose e tante relazioni aveva intrecciato.
Così decidemmo di accettare l’invito, andando a contestare Pizzo e Sullo nel loro “Cantiere”, in maniera pacifica ma determinata, ed iniziando una discussione, all’inizio determinata e incazzata, ma poi – come spesso succedeva allora – aperta all’ascolto e alla contaminazione.
Questo lungo e affettuoso ricordo per dire che, vent’anni dopo, la lupa perde il pelo, ma non il vizio:
Anna Pizzo, che Indymedia l’ha vista giusto da lontano (da vicino solo a Genova, ma con malcelata e scarsa sopportazione), nel sopracitato testo pensa bene di scriverne, chissà se parlando, o addirittura facendo parlare qualcun@ che Indymedia l’ha fatta?
Aspetto di poter leggere il libro, ma già temo quale possa essere la risposta… 😉